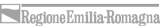Il volto di Archivio Zeta, un percorso spirituale dentro la pietà guardando a Dostoevskji
Renzo Francabandera | 09/09/2021 | Paneacquaculture
RENZO FRANCABANDERA | Torna meritatamente in replica a Villa Aldini di Bologna i prossimi 12 e 19 settembre Il volto, ultimo atto del progetto triennale Topografia Dostoevskij che la compagnia bolognese Archivio Zeta ha dedicato ai testi del grande scrittore russo e che si conclude quest’anno proprio in concomitanza con il bicentenario della sua nascita (1821-2021).
La drammaturgia originale è ispirata principalmente a suggestioni tratte da L’idiota e da un frammento di Delitto e castigo.
Lo spettacolo, come tutte le creazioni della compagnia, ha un potente riverbero ambientale, ed ha avuto in questa estate due allestimenti: quello ospitato al Cimitero Germanico della Futa, dove la compagnia ha potuto riprendere a fare spettacolo come da molti anni a questa parte, con la sola pausa dell’anno scorso, quando per la pandemia il luogo non fu concesso; il secondo allestimento, a cui si riferiscono queste riflessioni, è quello ambientato nella stupenda villa che l’avvocato Antonio Aldini, deputato della Repubblica Cisalpina e fedele di Napoleone Bonaparte, decise di far costruire nei primi anni dell’Ottocento per i futuri soggiorni bolognesi di Napoleone.

Il tema ambientale è cruciale in generale nella creazione spettacolare di Archivio Zeta, che abbiamo anni fa definito “architettonica” in una videointervista al duo registico. E ancora di più il rapporto con il luogo è fondamentale in questo allestimento, in cui le questioni etico-morali riferibili al sentimento della fine, alla cura per la fragilità umana e alla speranza si intrecciano in un dialogo con il circostante che in alcuni momenti diventa assolutamente spirituale.
La traccia dello spettacolo non è per così dire narrativa, seppure finga a tratti di esserlo, quasi ad attirare lo spettatore in un ambiente dentro il quale ci si aspetta una storia che non arriverà. Arrivano invece quadri, quadri che letteralmente vengono anche portati in scena per poi essere semplice cornice di un affresco dentro le tematiche più esistenziali della parola del grande romanziere; fino a partire all’intreccio fra autobiografia e scrittura che si riferisce a quello che sotto molti aspetti è il momento chiave della sua vita, ovvero l’arresto e la condanna a morte per attività sovversiva che Dostoevskij patì nel 1849, graziato quando ormai era davanti al plotone d’esecuzione.
A questo episodio, che sconvolse Dostoevskij, si riferisce il primo nucleo narrativo, ospitato nel prato antistante la villa, dove, attraverso le parole estrapolate sia dalle lettere al fratello che da alcuni passaggi espliciti de L’idiota, grazie alla sempre viva partitura sonora di Patrizio Barontini che da anni collabora con la Compagnia, e alle percussioni di Luca Ciriegi, si respira profondamente un’atmosfera drammatica e sospesa, in cui grazie ad alcune trovate sceniche semplici ma di grandissimo effetto, veniamo davvero catapultati dentro una scena gelida e di vita sospesa.
“In scena abbiamo un idiota-Cristo che torna in patria dopo un lungo soggiorno all’estero e una pittrice: davanti a loro si squaderna una San Pietroburgo innevata dove non esiste più il tempo e dove si materializzano le annunciazioni apocalittiche” dicono Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti nelle note di regia.
Da questo racconto legato al trauma biografico la traccia drammaturgica (come lo spettacolo) si sposta dentro quella che è a tutti gli effetti una riflessione sepolcrale sul tema del compianto, della trasfigurazione della morte sull’essere umano. Spunto di questa seconda parte della riflessione è anche in questo caso un quadro, Il corpo di Cristo morto nella tomba di Hans Holbein (1521).
La seconda scena dello spettacolo, si ambienta dentro uno dei gioielli architettonici e misconosciuti di maggior valore della città di Bologna, recuperato dallo stato di abbandono in cui versava proprio a seguito dell’intervento di iniziale bonifica delle aree destinate allo spettacolo da parte della Compagnia, un’azione meritoria di valore assoluto, un atto d’amore profondissimo verso la città e i suoi tesori, e che permette l’accesso ad un luogo stupendo: la Rotonda della Madonna del Monte, una chiesa sconsacrata in stile romanico a pianta circolare in cui sopravvive un’ampia superficie affrescata che per la maggior parte degli studiosi è databile fra il secolo XI e XII. Si tratta dell’unica parte sopravvissuta di un complesso conventuale di fondazione benedettina, la Madonna del Monte, appunto, edificato intorno al 1116 sul colle dell’Osservanza a Bologna e che, fra il 1400 e il 1700, ebbe momenti di grande splendore, e portò al convento un progressivo arricchimento in cappelle e affreschi oggi andati perduti: infatti nei primi anni del XIX secolo, come si diceva, durante il governo napoleonico, il convento venne demolito. Solo il piccolo gioiello della Rotonda sopravvisse, architettonicamente inglobato nella villa neoclassica.
È mozzafiato quindi l’ingresso in questo luogo segreto e sconosciuto, dove si riprende un altro pezzo di biografia dostoeskijana, ovvero la visione del quadro dipinto dal pittore Hans Holbein il Giovane, datato 1521, e che lo scrittore vide in Svizzera con Anna Grigor’evna Dostoevskaja, seconda e ultima moglie di Fëdor: lei stessperaltro di quella visione lasciò una palpitante testimonianza scritta.
A quell’incontro con il quadro, lo scrittore torna due volte ne L’idiota, affidandone una prima veloce descrizione al protagonista, il principe Myškin: «Quel quadro! esclamò d’un tratto il principe preso da un pensiero improvviso. «Quel quadro! Ma quel quadro potrebbe anche far perdere la fede a qualcuno!»; e poi successivamente una più approfondita e drammatica a Ippolit, nella parte III del romanzo, in cui si riflette sulla potenza della natura come macchina gigantesca che sovrasta il destino umano, simboleggiato proprio da una raffigurazione della drammaticità della morte di Cristo che è davvero troppo umana, in cui sono leggibili le torture, le sofferenze.
È per questo che la grandiosa, diremmo per certi versi sinfonica, pausa, il grande largo della scena successiva, la terza, con la visione angelicata e la rivelazione, il primo grande affresco muto della produzione di Archivio Zeta degli ultimi anni, irrompe con una potenza compositiva che è emblematica della maturità del linguaggio della compagnia.
La combinazione fra la scena terza e seconda segna la maggior differenza fra l’allestimento del Cimitero Germanico e quello di Villa Aldini, perchè nel primo dei due luoghi la scena viene, per via del pubblico più numeroso, sdoppiata, con una parte degli spettatori che fruisce quella che a Villa Aldini è la scena terza, ma percependo parte del sonoro della seconda, e poi inverte la fruizione con l’altra parte degli spettatori che era entrato nella cella. A Villa Aldini invece la costruzione ha una consecutio logica e formale che diremmo ineccepibile, che fa conseguire alla scena seconda dell’epifania sepolcrale, il tema della resurrezione, dell’angelo della terza scena.
Nella versione proposta a Bologna, la profonda ed equilibrata alternanza fra parola e silenzio, così come la rinuncia alla cadenza della parola proferita – che era stata cifra ampia della prima proposta del sodalizio Guidotti/Sangiovanni – a favore di una cadenza interna del lavoro affidata quasi completamente alla partitura musicale e ai silenzi, portano lo spettacolo a una silenziosa grandiosità, capace, come di rado avviene, di trasportare in modo compiuto la riflessione letteraria in un allestimento teatrale.
Quasi mai la parola dei romanzi trova nella declinazione scenica un riverbero felice. Il volto invece è uno di questi casi, un viaggio che condensa l’esperienza della Compagnia, ne matura il tratto e la potenza del freno dell’istinto creativo, a tutto vantaggio di un segno misurato, equilibrato, capace di farsi spirito, e quindi di avvicinare con assai più intensità a sua volta lo spirito degli spettatori.
Il finale ci riporta nello spazio antistante la villa ma si è dentro un camposanto, immagine che probabilmente al Passo della Futa avrà potuto riverberare di un senso drammatico e assoluto, ma che qui rimane un ambiente sospeso e onirico, in cui veniamo avvicinati al tema della speranza.
Il tema si ricollega alle parole che troviamo nelle note di regia: “In questi mesi che hanno sconvolto il mondo siamo stati costretti a incontrare gli altri senza mai mostrare il volto. Questo spettacolo è dedicato a tutti noi, senza volto, smarriti e isolati. Il teatro è il luogo aperto in cui vorremmo essere: il vuoto il verbo il nostro volto.”
Bene nel complesso la compagine attoriale, composta oltre che dai due registi e interpreti, anche da Andrea Sangiovanni, Giacomo Tamburini e Alessandro Vuozzo, cui si uniscono, come da alcuni anni a questa parte ormai in una delle rare realtà di famiglia di scena, anche i giovani e dotati figli Antonia ed Elio Guidotti, e anche la piccola Ida.