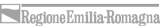Tragedia al Cimitero militare germanico
Massimo Marino | 07/08/2012 | Corriere di Bologna / BOblog

Tragedia al Cimitero militare germanico (Viaggi teatrali estivi 6 / Passo della Futa)
Dicono, gli artisti di Archivio Zeta, che mai un critico, in dieci anni, sia salito fin quassù, a vedere i loro spettacoli, le loro tragedie greche, tra le lapidi dei soldati e dei graduati tedeschi morti sulla Linea Gotica, in questo Cimitero militare germanico che si avvita fino a una costruzione che sembra il Walhalla disegnato dallo scenografo rivoluzionario Adolphe Appia.

Chiedono silenzio. Ascolto. “Faremo lo spettacolo insieme a voi, guardandoci negli occhi”. E nella salita, tra lapidi di giovani soldati, migliaia nel prato disseccato dall’estate, con qualche fiorellino di montagna e appena un alito di vento, con un senso di pace irreale, non si sente una voce. In cima, verso il sacrario, la cripta nera, il sancta sanctorum di questo luogo che ricorda l’offesa della guerra, lo sterminio e l’apparente pace di una democrazia sempre imperfetta, risuonano voci in una lingua sconosciuta, lontana, quel greco antico che ha formato la nostra fracassata cultura. Inizia il rito finale della tragedia della colpa e della vendetta, leEumenidi di Eschilo, ultima parte dell’Orestea, trilogia che fondava la giustizia dei tribunali, e la democrazia, sulla pietra dello splendore della polis, Atene, che aveva sconfitto nel sangue i persiani. Mettendo a confronto l’assassino della madre e le accusatrici, le Erinni, antiche deità della terra profonda, del ventre materno, qualcuno dice con i capelli di serpenti e veleno, in uno scontro apparentemente senza uscita: ho ucciso la madre che aveva ammazzato il padre. Vuoi più bene a papà o a mamma? Di chi sei figlio, di più? Chi dà la discendenza? Chi ha le chiavi del potere? Chi trasmette la roba?

È sorprendente questo spettacolo in mezzo ai boschi, in un luogo che ispira sentimenti contrastanti, la violenza cieca, per l’appunto, e la pace conquistata a prezzo di tante vite. È brechtiano, pasoliniano, ronconiano e perfino ispirato fortemente alle cartesiane, umanissime, aperte visioni ideologiche di quei geni che sono stati Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, brechtiani radicali di fine novecento. È freddo, straniato, semplicemente, con grazia, destabilizzante . Ma è pure qualcosa di originale, un atto poetico che riduce il testo antico all’osso per andare a scalfirne le incrostazioni e portarlo a quello che contiene di ancora vivo, di perennemente bruciante. Un “teatro di parola” come lo sognava Pasolini, capace di diventare rito democratico, controversa analisi per via di fantasmi dell’immaginario del nostro stare, singolarmente e in comunità, nel mondo.

Il greco antico ci porta a Delfi, nel misterico santuario di Apollo. Una sacerdotessa fornisce ogni spettatore, prima dell’entrata, di un misterioso sasso bianco. Intanto una musica di lastre di ferro suonate come violini ci attrae sempre più in cima, fino al chiuso, al buio della rivelazione del volere, della forza (ambigua) del dio. Qui un sorprendente Oreste vecchio, interpretato dallo stesso attore che due anni fa faceva Agamennone, figlio-padre passato attraverso le traversie della vita, padre-figlio, chiede pietà a Apollo, mostrando le mani, che dice purificate dal tempo e dall’espiazione. Dal pubblico, come figure di Dreyer, emergono le nere Erinni, donne dai volti comuni, quella giovanissima, la più anziana, l’altra un po’ sovrabbondante e la magretta. Voci di tutti i giorni che accusano con versi arcaici tradotti in frasi d’oggi.
Vagare ancora, deve, Oreste, e espiare: e presentarsi a Atena, che nell’agorà della città-faro della democrazia fonderà il primo tribunale che riscatti dall’occhio per occhio dente per dente, per inaugurare un mondo nuovo. Erinni saranno le accusatrici; Apollo, che armò la mano di Oreste, il protettore: in nome della logica patriarcale per cui uccidere il padre è più grave che ammazzare la madre, in quanto questa (per i greci, per lo stesso Aristotele) è solo una custode del seme, che dà l’imprimatur alla razza, alla gens, alla famiglia, all’individuo, alla società. Donne sconfitte, umiliate?

Il pubblico è chiamato a scegliere: può decidere se salvare o condannare Oreste, che continua a ripetere di essersi purificato. Il sasso, conservato dall’inizio, questa volta non servirà per una lapidazione. Molte spettatrici voteranno contro la legge del padre, senza ricordare il monito: nessuno tocchi Caino, e neppure la legge Gozzini e l’idea che il carcere deve emendare, non seppellire (purificato, dopo tanto tempo, continua a ripetersi Oreste). Il giustizialismo viene messo alla prova, e lo scontro tra vari fantasmi, la vendetta, la giustizia, l’uomo, la donna, con piana efficacia, attraverso parole isolate, scandite, lavorate, gettate, in quantità parca, contro il vento, a rimbalzare sulle architetture di pietra che ricordano una ormai lontana hybris, contro il silenzio, i monti, i morti, il sole che inizia a declinare.

E nel giudizio – si sa, è tutto scritto in Eschilo – vincerà Oreste, indipendentemente dai voti assegnati dal popolo: c’è subito qualche broglio, qualche trucco, per far trionfare la tolleranza, la democrazia, su quelle stesse basi ambigue di consenso misto a manipolazione e arbitrio su cui ancora si reggono. E poi le Erinni smettono i panni neri, e diventano ragazze, signore, anziane d’oggi, col tatuaggio, col camicione indiano, con lunga veste o jeans. Si mescolano al pubblico, dopo lo svelamento delle basi ambigue su cui si fonda la democrazia, sottolineando, con semplice, non insistita efficacia, come i mostri stiano sotto i nostri abiti quotidiani, gli odi antichi, il sangue e l’impossibilità o il desiderio di espiare stiano sempre con noi. Sotto la difficoltà di con-vivere. “I problemi – dice qualcuno – non si risolvono: si vivono”.
Rivelazione tra note di un piano sventrato, in uno spettacolo in cui i tanti riferimenti non diventano mai scolastici e la drammaturgia prova a disegnare un territorio per il nostro sentire, il nostro immaginare, il nostro faticato vivere oggi. Da vedere, gustare, ascoltare, meditare, rivedere, fino al 19 agosto (www.archiviozeta.eu).

Oreste è un professore di filosofia in pensione dalla bella faccia antica e montanara, Luciano Ardiccioni, con gli occhi glauchi come quelli della dea, la barba, i capelli lunghi, il dire essenziale e concentrato. Gli altri attori erano amatori: in dieci anni, col lavoro dei due registi-drammaturghi, Enrica Sangiovanni (ombra di Clitennestra e Atena) e Gianluca Guidotti(Apollo), sono diventati attori disuguali, particolari, veri, quasi sempre efficacissimi. Nel coro sono Giovanna Villa, Giulia Piazza, Marianna Cammelli, Rosanna Marcato, Luigia Savoia; i delegati del popolo sono Franco Belli e Alfredo Puccetti, due figure che sembrano scolpite nella pietra dintorno; la pizia è sdoppiata in Marianna Cammelli e Enrica Sangiovanni. Alle percussioni Duccio Bonciani e Luca Ciriegi.
Al Cimitero militare germanico del Passo della Futa, uscita dell’A1 Bologna-Firenze Pian del Voglio.

Le fotografie dello spettacolo (immagini 3-7) sono di Franco Guardascione