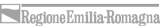Il teatro cacciato dal cimitero tedesco, trova casa a Bologna
Andrea Zangari | 21/07/2020 | Teatro e critica
Archivio Zeta non può proseguire il proprio lavoro storico al Passo della Futa, perché non ha ricevuto le autorizzazioni, ma la compagnia viene accolta a Villa Aldini, Bololgna. Intervista.

“Benvenuti a Villa Aldini a Bologna perché siamo stati cacciati senza giusta causa dal nostro Teatro di Marte par excellence”. Con queste parole Archivio Zeta, aka Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, annunciano sui social la loro ripartenza. C’è però il tono paradossale di un’avversativa nascosta: un saluto al luogo nuovo con lo sguardo ancora rivolto a quello che sono stati costretti ad abbandonare. Il 19 giugno, un altro post rendeva conto di una storia interrotta, quella che da diciotto anni legava il lavoro della compagnia al cimitero germanico della Futa. Luogo aspro, complesso nella sedimentazione di memoria e significati, ma anche complicato come un labirinto che immette infine al cielo, sulla vetta del passo scolpita come l’ala di un velivolo mezzo sprofondato nella terra, fra i 30000 corpi di militari tedeschi morti durante la Seconda guerra mondiale, mezzo appeso alle nuvole. Ci soffermiamo con Sangiovanni e Guidotti su quel percorso interrotto, forse pro tempore, come su macerie che è necessario compulsare, prima di affrettarsi a costruire strade nuove, ma instabili.
Come state? Sui social la reazione alla notizia del luogo negato è stata copiosa, ma come si sono mosse, in concreto, le istituzioni?
Stiamo bene ma siamo molto preoccupati perché senza lavoro da febbraio e con una grande famiglia da mandare avanti. In queste settimane abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere molte chiamate da parte di spettatori e amministratori locali che ci mettono a disposizione spazi di diverso tipo: ville, giardini, altri cimiteri… Moltissimi ci chiamano anche solo per chiederci che cosa è successo. È un bel segnale, sicuramente, ma questo non vuol dire che riusciremo a realizzare lo spettacolo. D’altro canto, la nostra filosofia non è di andare in scena ad ogni costo, un po’ per non allinearsi alla retorica dell’” andrà tutto bene“, un po’ perché non basta che gli enti mettano a disposizione uno spazio per “salvare la cultura”. È necessario un investimento. Certo non è facile trovare un luogo che abbia le stesse qualità del cimitero della Futa: se fosse stato solo un cimitero non ci avremmo lavorato per 18 anni. La sua spirale di pietra, che avvolge la cima della montagna per diverse migliaia di metri, per poi spiccare il volo in cima, è un simbolo del Novecento, ma anche dell’umanità ferita, con più di 30000 caduti fra i 16 e i 21 anni, ragazzi comuni “educati male” e mandati al massacro da Hitler lungo la Linea Gotica. Lo racconta bene Nora Krug in Heimat uno stupendo graphic novel uscito in Italia per Einaudi.
Ci sono dei parametri tecnici e “scenografici” irrinunciabili per accettare la proposta di uno spazio?
Se pensassimo a un luogo con gli stessi parametri della Futa, sarebbe una ricerca impossibile, è un luogo unico. Le opzioni che abbiamo preso in esame sono due: trovare un compromesso, adattando il lavoro per uno spazio altro dal cimitero germanico, modificare la drammaturgia e alcune scelte e andare in scena comunque, rischiando però di ricadere nell’idea che tutto si possa fare nonostante la situazione. Una seconda e più credibile opzione è riprendere un lavoro di repertorio: un’alternativa che ci pare obbligata, anche perché dobbiamo trovare il modo di continuare a lavorare. Andare in scena e far pagare un biglietto è l’unico modo che, come compagnia indipendente, abbiamo per finanziarci. Abbiamo un sostegno alla produzione da parte della Regione Emilia-Romagna e per finanziare i nostri progetti culturali, teatrali e editoriali partecipiamo a molti bandi pubblici. I parametri scenografici irrinunciabili sono questi: o siamo di fronte ad una scenografia di senso, cioè in un luogo che dialoga con il testo o che lo interroga, lo arricchisce di ulteriori significati oppure deve essere un luogo neutro, una camera oscura, senza le inguardabili sedie di plastica che con il distanziamento sono ancora più brutte o gli immancabili e orrendi leggii coi forelloni. Noi siamo estremisti e cerchiamo di rinunciare all’amplificazione e all’illuminotecnica, quando è possibile. Ci piace orientarci col sole e trovare delle risonanze naturali nello spazio che decidiamo di abitare. Sono scelte radicali ma che esprimono un punto di vista netto, ecologico: è una postura etica e politica, un segno. Siamo stati per anni ospiti del Teatro di Segesta, che è forse il teatro più bello del mondo. Chiedevamo di togliere tutto: gli orribili ring di americane, gli amplificatori che assordavano il paesaggio e annullavano i richiami delle cicale e delle capre. Ma è una lotta vana. Cioè il discorso è questo: se non ami le cicale, le capre, il sole che spacca le pietre o il vento, se non riesci a far entrare tutti questi elementi nella tua partitura, ma perché devi venire a recitare a Segesta o a Siracusa? Vai in una discoteca o in un capannone, è meglio per tutti. Questo vuol dire rispetto per i luoghi e le cose animate e inanimate che abitano quei luoghi.

La generosità della reazione indica che verso il vostro lavoro è nato un interesse specifico, che intorno ai Vs spettacoli è nata una comunità che di anno in anno riproduce un vero pellegrinaggio verso il Passo…
Il termine comunità è giusto, ci sembra riduttivo chiamarlo pubblico. È proprio l’essere stanziali in un luogo da 18 anni che ha portato questa comunità a formarsi. Il che è per certi versi paradossale: la Futa passa per essere un luogo da cartolina, ma non lo è affatto. È respingente, complicato sia per il suo significato ambiguo (è il luogo del nemico) che per le condizioni atmosferiche: in un attimo si può passare dal caldo torrido al freddo pungente. È un luogo che con il suo vento sferzante ha cambiato le nostri voci, i nostri corpi, ha dettato le caratteristiche dei costumi che usiamo in scena. Lavorando senza microfoni, nei primi anni ci andava sempre via la voce. È proprio questo che rende il Cimitero un luogo unico, non semplicemente “bello” o storicamente interessante. E forse qui sta l’equivoco alla base delle tante offerte di spazi che stiamo ricevendo. Noi non cerchiamo luoghi esteticamente piacevoli, non siamo guide turistiche né facciamo promozione del territorio, (quella forse è una conseguenza che dovrebbe venire colta dalle Istituzioni locali…). Noi cerchiamo luoghi significanti, magari anche terribili, degradati, per esempio scenari di archeologia industriale dai quali trasuda la decadenza nella nostra epoca, dove la crisi del lavoro dei nostri giorni appare come un dato materiale, dove risulta evidente il legame tra capitalismo e sfruttamento del territorio e degli esseri viventi. Oppure luoghi di memoria storica dove è necessario sostare, interrogarsi, senza retorica.
Sentite che in queste offerte, anche generose, ci sia un fraintendimento verso la natura del vostro lavoro da parte delle istituzioni?
Il fatto che per così lungo tempo abbiamo lavorato lassù, in una sorta di confino, all’inizio cercato e poi obbligato, lontani dalle stagioni dei teatri per una significativa parte dell’anno, ha fatto sì che spesso venissimo catalogati come compagnia stagionale. Siamo spesso percepiti come corpo estraneo nei cartelloni. E difficilmente siamo rientrati nei programmi dei festival. Certo, probabilmente siamo una realtà artistica non facile da classificare: i termini di teatro di ricerca, teatro popolare, prosa o contemporaneo… ci vanno stretti. Nessuna istituzione teatrale o festival ci ha offerto ospitalità, anche parziale. Solo singoli cittadini, persone, artisti o altre compagnie, piccole realtà (che magari vivono il nostro stesso disagio ma che ci hanno proposto con generosità la condivisione dei loro spazi). Le uniche istituzioni che ci sono state vicine da subito (anche con un sostegno economico) sono la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna. Insomma, da un lato ci siamo resi conto che il portato drammaturgico della Futa è praticamente irriproducibile in altri luoghi e dall’altro abbiamo percepito un assordante silenzio.
Di fatto vi siete trovati fra quelle realtà che non possono ripartire. Nelle ultime settimane è sorto un dibattito sulle criticità di una ripartenza a macchia, e sull’opportunità di concentrarsi piuttosto sulla fase creativa, magari in residenza, evitando messe in scena a sbigliettamento ridotto…Cosa ne pensate?
Tendiamo a non avere una posizione ideologica a riguardo, ma agire è necessario semplicemente per il fatto che, non agendo, scompariremmo. È evidente però che ci sono dei teatri, delle compagnie che possono permettersi di ripartire e altri no: questo rivela che il sistema attuale va smontato. I teatri finanziati dallo Stato dovrebbero sostenere chi fa una ricerca nel segno della dimensione pubblica. È un problema di politica culturale. Non è vero che, in generale, i fondi non ci siano: è che sono catalizzati dai quei pochi enti che riescono ad accentrare i finanziamenti italiani ed europei. Prendiamo il caso del Piccolo di Milano o dell’INDA, per fare due esempi di cartelloni in ripartenza con visibilità nazionale: è inutile difendere, produrre, ospitare spettacoli coi “big”, tutta gente che lavorerebbe lo stesso anche nel privato, andrebbero invece sostenute compagnie più piccole, meno famose, con progetti ambiziosi. La logica che viene messa in atto dalle direzioni artistiche è quella del consenso televisivo populista: di conseguenza quello che viene partorito è un prodotto para-televisivo, il che è controproducente per il teatro. D’altro canto i festival di ricerca sono arroccati in una strenua difesa della propria estetica rischiando una ossessiva autoreferenzialità, peraltro con un pubblico esclusivamente di addetti ai lavori.

Torniamo alla questione Futa. Come sono stati i vostri rapporti con l’ente gestore?
Quindici anni fa abbiamo mandato la prima richiesta direttamente al Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (l’ente privato che si occupa della gestione dei cimiteri militari tedeschi di tutta Europa, ndr). L’ente ha subito dato l’assenso, e dopo qualche anno ha avanzato la richiesta di un contributo (paradossalmente, invece che finanziare il nostro lavoro). Il ciclo triennale su Dostoevskij rientrerebbe in un progetto concordato col Volksbund per cui erano state già decise con precisione tutte le date, anche quelle del 2021. Così, giunti alla fine del lockdown, abbiamo contattato l’ente per chiedere di rimandare lo spettacolo di qualche giorno, per via dell’impossibilità di provare nei mesi passati. Per due settimane non abbiamo ricevuto risposte, poi è arrivata la notizia che lo spettacolo non si sarebbe potuto fare. Ci siamo attivati subito traducendo e inoltrando le normative in vigore in Italia, dimostrando che su suolo italiano lo spettacolo si sarebbe potuto fare senza problemi. Ma il cimitero militare è suolo tedesco, non c’è stato nulla da fare. Ancora un problema di sovranità, di confini, di nazioni: è sintomatico. È quello che è successo in Europa in questi mesi: invece di affrontare il problema del virus collettivamente l’Europa ha sospeso Schengen, ogni paese ha alzato barriere, una vera vergogna. Questo dimostra che siamo ancora lì, che continuiamo a pensare in termini di sopraffazione, di mors tua vita mea, di violenza.
In Germania, però, gli spettacoli in luoghi aperti sono consentiti. Secondo voi da cosa è motivata la restrizione che vi colpisce?
Crediamo sia semplicemente un eccesso di zelo. E anche un modo spiccio per non assumersi nessuna responsabilità: tanto la cultura non è un bene primario e quindi si può tagliare senza troppe conseguenze… Da qualche anno ci confrontiamo, per ogni spettacolo, con un responsabile della sicurezza che ha sempre mostrato interesse per il nostro lavoro ma anche una estrema rigidità, il che ci fa escludere si tratti di una scelta politica. Quello che tuttavia ci pare folle è che il cimitero sia aperto, e che le visite avvengano dunque senza alcun controllo.
Ho letto che avevate implementato il piano della sicurezza con ulteriori misure. Quali sono?
Da sempre abbiamo la prenotazione obbligatoria, il che previene il bisogno di una biglietteria, e quest’anno avremmo introdotto un’autocertificazione sullo stato di salute. Avremmo inoltre reso obbligatorie le mascherine, limitato la capienza a 60 spettatori (rispetto ai soliti 120-150), imposto una distanza interpersonale di 1,5 m. Lo abbiamo constatato in questi giorni andando a vedere altri spettacoli: spesso noi teatranti stiamo, paradossalmente, estendendo con grande senso di responsabilità le norme di sicurezza, mentre bar e locali sono allo sbaraglio.
Nei vostri lavori osservate le pieghe più tragiche della storia, sin dall’evocazione stessa che la spazialità del cimitero della Futa costituisce. Anche questa che stiamo vivendo è una tragedia? Credete che sia possibile portarla nei vostri lavori futuri?
Non lo sappiamo ora. Siamo abituati a lavorare attraverso il filtro di un materiale letterario prodotto da qualcuno che ne sa molto più di noi. Spesso è successo di trovare questa materia in testi classici, Sofocle e Eschilo soprattutto, ma anche in autori moderni come Karl Kraus, Pasolini, Dostoevskij appunto. L’attualità ha bisogno di un tempo di deposito per essere raccontata, per diventare materia artistica, ma è anche vero che ogni materiale letterario contiene un potenziale drammatico. Per esempio quello che sta scrivendo in questi mesi Paul B. Preciado su Libération è molto potente, sia a livello filosofico che poetico. Forse non servono i classici per parlare di questo tempo, si potrebbe partire da un reportage, una lettera, una commistione di fonti…

Per voi la Futa resta un luogo a cui tornare, o questi 18 anni sono giunti ad un punto?
Vogliamo e dobbiamo tornarci. Appunto perché basta un virus per ripiombarci ad alzare muri e a sostenere che ci sono persone sacrificabili. Insomma siamo sempre quelli della banalità del male. Un luogo così storicamente scomodo e complesso non può essere lasciato a nostalgici e negazionisti, o al semplice turismo. In quel luogo vale la pena fare un discorso culturale sul razzismo, l’intolleranza, l’autoritarismo dei giorni nostri e sulla nostra educazione europea che ci fa accettare i morti in mare e gli accordi con la Libia. Fare un discorso culturale alla Futa è un’occasione per non farlo in modo retorico, ma nella concretezza della morte e dell’architettura che si ha intorno. Il cimitero della Futa è un luogo che parla di dolore e di sconfitta. Un tragico coro silenzioso ha orientato le nostre scelte.
Andrea Zangari