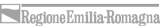Pro e contra Dostoevskij: l’acto de fe nelle ragioni dello spirito di Archivio Zeta
Renzo Francabandera | 06/08/2019 | Paneacquaculture
Tre figure monacali, quelle che popolano il cuore de I fratelli Karamazov di Dostoevskij, accolgono il pubblico dentro lo spazio del Cimitero Germanico alla Futa, ricevendo da una bambina dei grandi pani di farina bianca che, dopo una passeggiata in questo luogo senza tempo di vita, i monaci restituiranno alla terra, salmodiando una melodia ancestrale; un gesto ripreso dal finale del romanzo in cui Alësa ragiona sul mettere sulla tomba di un bimbo morto una pagnotta.
Un ciclo eterno, in cui l’uomo, con il suo transito, così effimero se confrontato all’eternità, svanisce dentro la vicenda della specie umana, un nulla nel tempo dell’universo.
Ma poi, cambia l’uomo?
Evolve?
Lo spazio del Cimitero in cima alla collina del Passo della Futa è lo stesso da più di un decennio ormai. Eppure ogni volta, ogni anno, riesce a essere sempre diverso nei visionari e per certi versi postmoderni allestimenti del duo Sangiovanni/Guidotti: basta cambiare un punto di vista, cosa cui loro sono attentissimi, basta cambiare elemento, la disposizione degli uomini e delle cose nello spazio e ogni anno si assiste a qualcosa sempre differente. Sono ovviamente i testi, quasi meditazioni sul transumanesimo, a sconvolgere chi viene a immergersi in questo silenzio assoluto.
Di fondo l’angosciante spettacolo – e scriverlo fra virgolette è assolutamente inutile – dato dalle migliaia di tombe nella terra in cui sono sepolte le vittime di guerra. Sono quelle di parte tedesca morte in Italia, e che durante la seconda guerra mondiale combatterono per Hitler. Sono 30 mila.
A leggere le date di nascita su quelle pietre si capisce che furono migliaia e migliaia di ragazzi poco più che maggiorenni. A quell’età come si fa a sapere ciò in cui davvero si crede? Cosa significa credere? In un’idea? A questi bambini andava posto il pane sulla tomba.
 Ambientare in questo luogo una riflessione sul tema politica-morale-società sulle soglie dell’inevitabile catastrofe, Cassandre del rischio dell’umanità di estinguersi, è quello a cui si dedica da molti anni la compagnia teatrale Archivio Zeta, che a lungo ha avuto sede proprio in questo territorio, prima di spostarsi da qualche anno a Bologna.
Ambientare in questo luogo una riflessione sul tema politica-morale-società sulle soglie dell’inevitabile catastrofe, Cassandre del rischio dell’umanità di estinguersi, è quello a cui si dedica da molti anni la compagnia teatrale Archivio Zeta, che a lungo ha avuto sede proprio in questo territorio, prima di spostarsi da qualche anno a Bologna.
È rimasta la pratica dello spettacolo nello spazio cimiteriale, portato in scena ogni anno in questo luogo pazzesco, da cui si gode una vista dell’Appennino tosco emiliano formidabile, fra vette, laghi, vallate. E quando il tempo è variabile, come è stato a luglio, gli squarci dei raggi di luce fra le nuvole sono davvero emozioni che si aggiungono alla parola scenica, per trasferire a chi sa viverle, esperienze indimenticabili.
L’allestimento di quest’anno è centrato su riflessioni intorno all’uomo come luogo delle intenzioni, l’essere umano come animale senziente ma corruttibile, dibattuto in una lotta manichea tra bene e male. Archivio Zeta riflette sul ruolo della mistica e del sacro nell’indirizzare l’individuo verso l’uno o l’altro. E lo fa ricorrendo al rimando diretto, potremmo dire quasi letterale, a due testi del grande scrittore russo, La Leggenda del Grande Inquisitore e Sogno di un uomo ridicolo.
Dal punto di vista del movimento nell’ambiente, il percorso si configura come una vera e propria ascensione, iniziando dalla parte bassa della collina, fino ad arrivare in cima: una ascensione guidata dalle tematiche tratte principalmente dal libro V della parte II de I fratelli Karamazov (il cuore tragico del romanzo e che si intitola appunto Pro e contra).

Il viaggio di Dostoevskij attraverso l’Europa di un secolo e mezzo fa, nel 1862, fu motivo di grande stravolgimento per lui, e non dubitiamo lo sarebbe anche oggi.
Archivio Zeta ci ripropone, in un ragionato e profondo collage letterario, la stessa terribile angoscia dello scrittore, che diventa, ora, quella della intera collettività, la stessa che in fondo aveva crocifisso Cristo duemila anni fa e che, si lascia intendere nella ripresa del racconto Leggenda del Grande Inquisitore, non esiterebbe a rifarlo.
Siamo un’epoca che torna a crocifiggere l’anelito dello spirito, e tanto la società quanto l’individuo vivono la grande e dolorosa divisione fra egoismo e altruismo, fra mutualità solidale e indifferenza sprezzante.
Se si possa moralmente e fattualmente andare al di là del bene e del male, superare il dualismo manicheo è il grande interrogativo che resta in questo luogo che, certo nella calma del riposo infinito delle anime, ci induce a interrogarci su cosa fosse davvero giusto per loro; a chiederci se avrebbero potuto cambiare idea o se sapessero davvero per cosa stessero combattendo.
In fondo persino in croce, pare che Cristo abbia invocato perdono per l’umanità, ignara di ciò che stava compiendo. Ma quando possiamo perdonarci senza assolverci dal nostro compito di far evolvere lo spirito dell’uomo?  L’individuo angosciato, interpretato da un taciturno e poi febbrile, delirante Gianluca Guidotti, seduto solo, in cima alla collina, nella sedia del suo immaginario appartamento, osserva taciturno l’umanità ascoltare, non senza fatica, dispute filosofiche su bene e male, giustizia ed ingiustizia. Poi gli stessi protagonisti della scena iniziale, che quasi ci aiutano a varcare il regno delle anime, ci portano fino al sogno delirante dell’artista, dentro le prima cinta di mura del cimitero, per poi salire nella rocca, dove assisteremo alla vicenda dell’Inquisitore, mista all’incontro fra l’uomo e il demonio (una mefistofelica e mascolineggiante Enrica Sangiovanni). Gli stessi pani seminati nella prima scena, quel richiamo al rito infinito della terra, diventano, nel processo all’Inquisitore, pietre nere, da cui però il Cristo saprà di nuovo ricavare pane, nutrimento celeste. Che è proprio il ruolo dello spirito. Ridare vita a ciò che è arido, inaridito dal parassitismo sociale, incarnazione del demonio.
L’individuo angosciato, interpretato da un taciturno e poi febbrile, delirante Gianluca Guidotti, seduto solo, in cima alla collina, nella sedia del suo immaginario appartamento, osserva taciturno l’umanità ascoltare, non senza fatica, dispute filosofiche su bene e male, giustizia ed ingiustizia. Poi gli stessi protagonisti della scena iniziale, che quasi ci aiutano a varcare il regno delle anime, ci portano fino al sogno delirante dell’artista, dentro le prima cinta di mura del cimitero, per poi salire nella rocca, dove assisteremo alla vicenda dell’Inquisitore, mista all’incontro fra l’uomo e il demonio (una mefistofelica e mascolineggiante Enrica Sangiovanni). Gli stessi pani seminati nella prima scena, quel richiamo al rito infinito della terra, diventano, nel processo all’Inquisitore, pietre nere, da cui però il Cristo saprà di nuovo ricavare pane, nutrimento celeste. Che è proprio il ruolo dello spirito. Ridare vita a ciò che è arido, inaridito dal parassitismo sociale, incarnazione del demonio.
Ne I fratelli Karamazov, infatti, anche se per poche pagine, entra in scena questa presenza demoniaca, che allontana l’uomo dall’assoluto, spingendolo verso la pazzia e l’autodistruzione. Si tratta di uno dei rarissimi casi in cui appare il diavolo fra le opere della letteratura moderna: oltre il Faust di Goethe e Il Maestro e Margherita di Bulgakov, fra la metà del XIX e la metà del XX secolo, questa figura quasi scompare dal letterario.
Qui viene ripreso l’episodio in cui Ivàn Karamazov, alla vigilia della deposizione che intende fare al processo del suo fratellastro Dimitrij – quando rivelerà davanti alla corte la responsabilità di Smerdjakov nell’assassinio del padre, assumendosene però, se necessario, la paternità morale – ha un faccia a faccia con il diavolo, in casa sua, mentre è in preda alla febbre cerebrale.
Contro il tedio, il diavolo parassita si offre quasi come amico, alleato nella lotta alla noia. Seduttivo e intelligente, getta le sue esche, restando sospeso fra reale e immaginario, lasciando all’uomo l’illusione di essere lui ad autodeterminarsi, in modo che sia più facile conquistarlo. Di questa incapacità di riuscire a indirizzarsi verso lo spirito e di cedere alla bassezza umana (quindi potremmo dire demoniaca nella visione di Dostoevskij, mutuata da Archivio Zeta) resta all’individuo corrotto dalla noia mefistofelica un vago senso di vergogna, che, talvolta, quasi inspiegabilmente, assale l’uomo.
Provo solo vergogna (…) ma non so di che cosa, dice Ivàn a se stesso.
 Quanto la parola del grande scrittore russo sia “scenica” questo è tema controverso, su cui personalmente ho un punto di vista restrittivo, perché alcune cose si comprendono e si “assorbono” solo nella lettura, nella possibilità finanche della rilettura, mentre nell’offerta della parola in prosa, non è “permesso” all’ascoltatore/spettatore il dire: “fermati, ripeti, non ho capito, voglio risentirla”. Forse potrebbe essere una frontiera futura, quella in cui lo spettatore arresti lo spettacolo per comprendere oltre, per risentire la parola, provare a farla propria. È il grande tema della filosofia a teatro.
Quanto la parola del grande scrittore russo sia “scenica” questo è tema controverso, su cui personalmente ho un punto di vista restrittivo, perché alcune cose si comprendono e si “assorbono” solo nella lettura, nella possibilità finanche della rilettura, mentre nell’offerta della parola in prosa, non è “permesso” all’ascoltatore/spettatore il dire: “fermati, ripeti, non ho capito, voglio risentirla”. Forse potrebbe essere una frontiera futura, quella in cui lo spettatore arresti lo spettacolo per comprendere oltre, per risentire la parola, provare a farla propria. È il grande tema della filosofia a teatro.
Non v’è tuttavia dubbio che esistano suggestioni assolute, immense, la cui ricchezza aggiunta alla parola diventa pericolo; come non v’è dubbio che qualcosa resti dentro qualcuno, sempre, qualcosa che porti poi ad incuriosirsi, a cercare nutrimento, il dialogo con quella curiosità bambina che ci abita dentro.
Forse è la stessa bambina, quella della semina iniziale, quella che incontra lo scrittore nel suo delirio salvandolo dal suicidio, che lo condurrà, tenendolo per un filo mentre cammina sul muretto del camposanto, a fare i conti con se stesso. In fondo l’individuo, di fronte ai grandi temi dell’eterno, dell’assoluto, è solo. Forse il recupero dell’istinto innocente può tessere quel filo dorato fra l’adulto e lo Spirito. L’Assoluto.