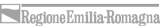Pilade al Cimitero Militare Germanico della Futa
Massimo Marino | 09/08/2015 | Corriere di Bologna / BOblog

Pilade al Cimitero militare germanico della Futa
Nuvole. Vento leggero. Monti. Silenzio. Un campo, poi un altro. Tombe nel prato verde e giallo secco per il caldo di agosto. Pietre tombali in file regolari. Un lumino. Una piccola corona appassita. “Non siamo certo inesperti di sangue, noi”, dice, come una domanda, come un’affermazione che nell’uscire si spaventa del proprio tono violentemente assertivo l’uomo che ci conduce, con una barba caprina e capelli folti e scarmigliati, all’aspetto un contadino o un rivoluzionario di altri tempi. La compagnia teatrale Archivio Zeta ci fa guardare, con Pilade di Pasolini, anzi con un episodio tratto da quel testo, Pilade/Boscocimitero, la distesa di tombe di soldati tedeschi, spesso giovanissimi, spesso senza nome, seppelliti nei campi che si arrampicano verso la cima del colle, in quel Cimitero militare germanico della Futa, tra Firenze e Bologna, nella terra e vicino al cielo, sacrario e monito alla ferocia, all’insensatezza della guerra. Vi sono sepolti più di 36.000 militari caduti nell’ultimo conflitto, in gran parte sulla Linea gotica. Gli oppressori, ora solo polvere e meditazione sul macello della guerra tecnologica.

In un teatro di Marte
L’anno scorso Archivio Zeta, Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, con alcuni non attori che li seguono nelle loro imprese e con il fine musicista Patrizio Barontini, avevano rivolto lo sguardo, dopo anni di affondi sulla tragedia greca, agli Ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, la denuncia proprio dello sterminio di massa della Prima guerra mondiale, propiziato dalla grande industria e eccitato dai mezzi di comunicazione. Ora torna in questo “teatro di Marte” (così Kraus chiamava il luogo dove rappresentare il suo fluviale testo fatto di centinaia di pagine di discorsi colti da una realtà incredibile), sito inconcepibile di memoria dell’orrore, che loro hanno eletto a teatro naturale, spazio per esercitare l’immaginazione, la parola riflessiva, le arti della visione, sostenendole con il bordone di questa teoria di morti per causa ingiusta, di morti assurde. L’attore non ha bisogno di fare, di dire molto, qui: deve solo interrogare il silenzio, e declinarlo verso un pensiero. Sarà lo spettatore a rilanciare dentro di sé, a connettere, senza riuscire a non vedere colorarsi di sangue quel paesaggio idillico.
Quest’anno gli Archivio stanno lavorando al Pilade, opera che Pasolini scrisse nel 1966 e che più volte rimaneggiò, rimanendone sempre insoddisfatto, una prosecuzione dialettica, secondo i principi del suo teatro di parola, dell’Orestea di Eschilo, un testo che parte dal nuovo patto di democrazia instaurato da Atena dopo l’assassinio di Agamennone, il matricidio per vendetta di Oreste e la sua espiazione. Non lo mettono in scena integralmente, ma lo spezzano in quattro episodi ambientati in posti diversi (abbiamo già parlato di quello di Saline di Volterra, Pilade/Campo dei rivoluzionari). Il loro è un teatro dei luoghi e delle parole che scavano il silenzio, con bagliori che sembrano ispiratati al cinema minimalista, di interrogazione umana e metafisica, di Robert Bresson e al discorso politico di due altri maestri dalla ruvida, rivelante essenzialità, Danièle Huillet e Jean-Marie Straub. Dopo Monte Sole, le Saline di Volterra, con gli operai licenziati della Smith Bits, questo è il terzo atto, cui seguirà un quarto di fronte a villa Aldini, la costruzione neoclassica sul colle di San Mamolo a Bologna dove Pasolini girò Salò, oggi centro di accoglienza per migranti (saranno loro i coreuti). Il tutto si ricomporrà in un’unica giornata, il 2 novembre, 40° anniversario dell’assassinio del poeta all’idroscalo di Ostia, con un percorso in quattro diversi luoghi di Bologna.

Un dramma della ragione?
Intanto ci guida, Pilade, tra le tombe, verso il sacrario che si erge in cima al colle come una casamatta di pietra scura, dalla quale svetta un’ala che sembra lanciarsi in volo e spezzarsi. Una costruzione in cui pietre diverse creano cromaticamente un effetto di movimento, quasi un’utopistica scenografia wagneriana alla Adolphe Appia. In questo episodio Archivio Zeta ha attinto all’inizio dell’opera, all’instaurazione ad Argo del dominio della nuova dea, la ragione, Atena, sovrintendente al giorno, ai mercati, alle attività umane, al progresso, che chiama il popolo alla responsabilità intimorente della democrazia. Ci ritroveremo, alla fine della pièce di Pasolini, ad ascoltare lo smagamento di Pilade, la sfiducia, il dubbio crepuscolare su cosa sia da fare, su come la ragione sia spesso potere esercitato ingiustamente e di come dal potere bisogni tenersi lontani. Fa da cesura un pezzo registrato con la voce di Pasolini sopra un inno sovietico e il twist della Ricotta. Chiuderanno le parole del poeta, in contrappunto con l’enunciazione della sfiducia nella ragione, “Io sono una forza del Passato. / Solo nella tradizione è il mio amore…”, famosi versi da Poesia in forma di rosa detti da Pasolini stesso come una lancinante domanda alla nostra contemporaneità e a queste montagne avviate verso il crepuscolo.
Si avverte una cesura drammaturgica tra le due parti: non si segue l’azione che porta Pilade alle considerazioni finali e un ingresso di Oreste, interpretato dalla stessa attrice che dà corpo ad Atena, può ingenerare qualche effetto di confusione. Ma qui non è la trama che conta. È la costruzione di un montaggio dei pensieri per sprazzi poetici, la ricerca di una dialettica del presente per emozioni. È il modo in cui i versi di Pasolini diventano affilati oggetti che ci penetrano, e squarciano pozzi di riflessione. Quella dea non tenuta per mesi nelle viscere materne come un qualsiasi animale, divinità della luce, ha già dall’inizio in sé una promessa di futuro e di orrore. Ha già qualcosa della bomba atomica nel suo luminoso apparire, dello sterminio di massa, delle bombe “chirurgiche”, della Grecia umiliata dall’Europa, ricordata quando Oreste, in controluce con il gran faro del sole, innalzerà la bandiera ellenica sotto quella dell’Unione Europea che svetta, con la tedesca, l’italiana e quella dei cimiteri di guerra germanici, da un pennone.

Atena (Enrica Sangiovanni) è doppia: una bambina in rosso (Antonia Guidotti), ingenua, misteriosa, che guarda l’orizzonte, e una donna avvolta in un lungo mantello, con l’espressione corrucciata e una lancia nel pugno. Con Pilade (Gianluca Guidotti) dialoga a distanza, grazie a un sistema di diffusione del suono in cuffia che porta lo spettatore/ascoltatore vicino alla voce meccanica degli dei e del mito, con inserti rumoristici o seriali che irruvidiscono note di sonate barocche, nel congegno sonoro di Patrizio Barontini. Dialogano, come fossero vicini, Oreste (controfigura di Atena) e Pilade, a cento metri di distanza, mentre lo spettatore è rimandato in continuazione da sé (la voce) all’immagine alle nuvole e alla luce, agli odori di erbe di montagna. Spazio, parola, idea, figure: cortocircuiti continui, colori di una tavolozza che rapisce.

Verso il tramonto
Un ragazzo (Elio Guidotti) conduce un uomo dalla barba bianca (Alfredo Puccetti) per i sentieri del cimitero, in secondo piano, con poche parole, in un cammino che porta non sappiamo dove. Noi intanto, dopo la voce di Pasolini che parla del progetto di un nuovo paese, da costruire facendo, con l’esperienza, con riferimento alle speranze dell’Italia del dopoguerra, siamo stati condotti nel sacrario. I monti e il lago sullo sfondo sono colorati dolcemente dal sole calante. In controluce diventano, oltre il muro cui è appoggiata una scala, una massa scura, ritmica, una visione di apertura e di minaccia. Come la ragione, protagonista del finale, con il bambino e il vecchio che si addormentano, lasciando Pilade solo con tutte le sue domande su come si possa governare il mondo, le cose, gli uomini puntando sulla luce, quando siamo avvolti nell’ombra, nel fallimento, e le dee Eumenidi, messe a protezione della nuova città, spesso rivelano ancora la loro natura di Furie selvagge. Solo l’incertezza, l’umana incertezza fa da sicura compagna all’eroe, infreddolito da un cammino di esperienza e dolore che qui non abbiamo visto, che tornerà negli altri episodi, in un finale che non gode più neppure della consolazione catartica e effettistica degli umori violenti della tragedia. In un crepuscolo, in cui la protesta è stare in un angolo di mondo, lontano dal potere.

ph. Castorp
Archivio Zeta ha sviluppato una meditazione poetica che vive dei diversi elementi ricordati. Scava dentro, rimane impressa come dolore e speranza, come domanda, con quel modo di recitare che sembra misurare, dilatare le vocali, stupirsi del loro collegamento con le consonanti e nelle parole, che potrebbe apparire enfatico e che invece è un’analisi del linguaggio, una sua destrutturazione, una richiesta ai meccanismi abitudinari di emissione della voce e di ascolto di interrompersi, di riflettersi, di trasformarsi in questioni, associazioni, pensieri, domande. Come quella, irrisolvibile, che pone questo luogo, il sole calante sulle gesta umane, sull’affannarsi e il ritrarsi, sul guardarsi dentro “per figure”, per tentare di rimandare, almeno un po’, l’apocalisse dell’umano.
“Lascia ch’io pianga / mia cruda sorte, / e che sospiri / la libertà” canta Cecilia Bartoli, mentre i personaggi svaniscono o si addormentano, Händel straziante nella bellezza del creato, nell’oscuro avvoltolarsi di Pilade nelle impossibili risposte, nella forza del Passato evocato girando “come un cane senza padrone” nei suburbi della contemporaneità, irrorata da quella sospensione dubbiosa sul futuro possibile.

Fino al 16 agosto alle 18 al Cimitero militare germanico della Futa. Pullman da bologna l’11 e il 15 agosto. Informazioni e prenotazioni qui.
Le fotografie, salvo indicazione contraria in didascalia, sono di Franco Guardascione.