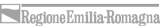LA NOTTE @Risiera di San Sabba: il rito di Archivio Zeta è compiuto
Leonardo Favilli | 07/10/2023 | Gufetto
LA NOTTE: OLTRE LA TESTIMONIANZA

Eccola, LA NOTTE: sette sedie e sette lampade a piantana davanti al glaciale alto muro grigio che delimita il fondo del cortile. Non potrebbe esserci scenario più asettico per iniziare. “Così cerchiamo di prendere un po’ di Silenzio, poche Parole e parliamo”: nel video proiettato sulla parete la voce di Elie Wiesel, sopravvissuto al campo di sterminio e autore de La Nuit, getta le basi per un percorso narrativo e drammaturgico che ha dosato con sapienza e con profondo rispetto voci e silenzi. Perché ci stiamo affacciando ad un frammento di storia in cui l’ineluttabilità della parola si fa pesante fardello, limite umano per raccontare la crudeltà programmatica dell’uomo stesso. LA NOTTE non è solamente una bruciante testimonianza: è esperienza disumana, è stravolgimento di valori, è violenta catarsi che, ARCHIVIO ZETA, nella semplicità dell’impianto drammaturgico ha saputo narrare, ha saputo gridare, pur nel silenzio che ci lascia nelle orecchie il fruscio del vento di una serata di metà settembre, e nelle viscere uno squarcio profondo.
I PASSAGGI SALIENTI NELLA NARRAZIONE DE LA NOTTE
Come in una cerimonia, si distribuiscono i libretti ad ognuno degli attori in scena con la propria sedia e la propria lampada. Il rito ha inizio. La narrazione principia dal rapporto di Wiesel ragazzino con il responsabile della sinagoga locale in un piccolo paese della Transilvania, dove l’autore è nato e dove si avvicina al culto ebraico, appassionandosi alla Cabala. Il racconto dell’esperienza dell’uomo che era stato deportato in Polonia ma poi era riuscito a fare ritorno al paese, sembra inizialmente solo un brutto sogno ma presto diventerà incubo reale contingente; insieme alla donna del treno che ha la visione di fuoco e fiamme, come in preda ad un raptus: Cassandre del romanzo, testimoni inascoltati ma tristemente profetici. Anche la famiglia di Wiesel viene rastrellata nel ghetto di Sighet e deportata ad Auschwitz, dove la madre e la sorella troveranno subito la morte nella camera a gas, mentre il giovane Eliezer resterà col padre, che sopravvivrà anche alla marcia della morte fino al campo di Buchenwald dove purtroppo, però, perirà poche settimane prima della liberazione.
LA PRESA DI COSCIENZA DI ELIE WIESEL

Gli attori, 6 in scena, hanno lasciato un’unica sedia, la settima, vuota al centro con la sua luce e si muovono con i loro libretti nello spazio oppure restano seduti al proprio posto, occupandosi di portare sempre con sé la lampada. Passano da un personaggio all’altro, da un episodio all’altro, in una selezione dall’originale che niente toglie alla potenza lancinante del romanzo, senza alcuna velleità di prevalere sulla parola scritta. D’altronde, non c’è bisogno di retorica, tutto è già nero su bianco. Si aggiungono le note di Monteverdi e di alcuni inni e canti del popolo ebraico, oltre al silenzio, tanto pesante quanto le spoglie umane che gli internati nel campo sono costretti a trascinarsi: scheletrici nell’aspetto ma abbattuti da quel corpo che sembra un fardello insopportabile. Dalla notte del rastrellamento a quella del bestiale viaggio in treno verso il campo fino all’evacuazione della Buna, la fabbrica di gomma del campo di Auschwitz cui Wiesel, matricola A7713, era stato destinato, la vita si trascina da un’ultima notte all’altra. Senza più nessuno spazio per la luce, neanche quella divina. La divinità cui Eliezer si era avvicinato da ragazzino grazie allo Shammash, il servitore della sinagoga del suo paese, sembra restare indifferente all’orrore. In una sorta di epifania al contrario, l’immagine indelebile dei deportati che intonano per loro stessi preghiere dedicate ai defunti e l’orrore della pira cui vengono destinati carichi di bambini, darà all’autore la certezza che Dio non può esistere.
Qualcuno si mise a recitare il Kaddìsh, la preghiera dei morti. Non so se è già successo nella lunga storia del popolo ebraico che uomini recitino la preghiera dei morti per se stessi.
GLI ATTORI DE LA NOTTE: CERIMONIERI DI UN RITO COLLETTIVO

Nel cortile che ha ancora dolore da spurgare, gli artisti in scena hanno saputo farsi cerimonieri rispettosi, umili ma responsabili di un rito collettivo del quale ci sentiamo tutti partecipi mentre le parole – sempre loro, ineluttabili ma inevitabili – si susseguono, pagina dopo pagina, da quei libretti che assumono una sacralità spirituale. Laddove i passaggi del romanzo diventano meno narrativi e sfiorano le corde profonde della sensibilità umana, è la voce dello stesso autore ad intervenire con i contributi video in lingua originale francese che erano stati registrati all’esordio del progetto. Il risultato è un suono dissonante, ossimorico, in cui le corde sono letteralmente violentate e non ci viene risparmiato nulla di questa violenza. Non servono effetti speciali o trovate plateali: il muro in fondo al cortile della Risiera è nuovo Muro del Pianto e le 7 lampade in scena diventano altrettante braccia del candelabro rituale ebraico, che si spengono ad una ad una alla fine, tranne l’ultima, quella al centro, la lampada che accompagna la sedia per l’autore. Una luce flebile, unico segno di speranza ma tanto debole da richiedere l’impegno di tutti per mantenerla ancora viva.
IL RISPETTO E LA PROFESSIONALITÀ DIETRO LA DRAMMATURGIA DI ARCHIVIO ZETA

L’attenzione, la sensibilità e la profonda professionalità che Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti hanno ancora una volta espresso nella costruzione di questo progetto confermano che la realtà di Archivio Zeta è un patrimonio umanitario. Sarebbero bastate le righe incise a caratteri di fuoco da Elie Wiesel, magari davanti ad un leggio col quale interagire per una lettura recitata del testo. Si è scelto invece ancora una volta di elaborare, metabolizzare e soprattutto rispettare, e il testo e il pubblico. Questo con una processo drammaturgico che ha superato la mera lettura di testimonianza; quello, con un’interpretazione che grida senza strillare, che lascia risuonare quei mattoni e quei muri come risvegliando il dolore di cui sono madidi. Se non è possibile lavorare sul piano puramente narrativo, lessicale, restano altri livelli comunicativi sui quali gli artisti di Archivio Zeta hanno dimostrato negli anni di sapersi abilmente muovere. Stavolta la scelta è far parlare il silenzio e la luce, e non avrebbero potuto trovare soluzione migliore. Non senza violenza per gli attori che al termine non riescono a nascondere la tensione, quella stessa che nel frattempo si è in noi sciolta con la commozione, intrattenibile e violenta.
All’uscita della rappresentazione – non chiamiamolo spettacolo – inizio a salire il dorsale della collina e non riesco a trattenermi: mi volto ad osservare la Risiera dall’alto. E mi sembra ancora di sentire quelle parole uscire dal cortile, come 80 anni fa avrei potuto ascoltare le grida dei morituri e nausearmi di carne bruciata nella volatilità della fuliggine.
Visto al Museo della Risiera di San Sabba (Trieste) il 19 settembre 2023