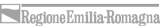Crisi. Inflazione. Deflazione. Stagnazione. Spread. Flessibilità. Crescita. Debito. Credito. Banca. Banche. Borsa. Finanza. Azioni. Capitale. Mercato. Valuta. Moneta. Denaro. Ricchezza.
Diciamoci la verità, non è che ci destreggiamo proprio bene bene in questa giungla di termini. Li confondiamo. Proviamo a fidarci di quel che scrivono i giornali, anzi, ci affidiamo spesso a quel che riportano i politici nei talkshow, dando per buoni dati di cui non conosciamo l’attendibilità né tantomeno la portata: un punto percentuale di PIL, onestamente, chi lo sa a quanto ammonta, e quant’è? tanto? poco? cosa ci si può fare? cosa no? Insomma, in tutta ignoranza, finiamo per usare una parola per l’altra, per capire una per l’altra, per poi, in conclusione, disinteressarcene lapidariamente: sono tutti ladri. Alé. Amen.
Eppure di per sé l’economia è scienza nobile. «Uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere» dice la Treccani «il massimo vantaggio a parità di dispendio o lo stesso risultato col minimo dispendio». Seconda definizione? «Parsimonia». Etimologia? «Amministrazione delle cose domestiche, ordine, distribuzione.» Ma allora perché instilla tanta acredine e diffidenza?

Mafalda – ©Quino
Probabilmente perché la «distribuzione» tanto equa non è. E non è certo un fatto recente. Già 2400 anni fa Aristofane affrontava la questione nel Pluto in forma di commedia, portando acutamente il ragionamento, tuttavia, alle estreme conseguenze. Il mondo è povero perché il dio della ricchezza Pluto è un dio cieco e in male arnese. Accade così che il vecchio ateniese Cremilo col suo servo Carione lo intercettino e lo conducano al tempio di Asclepio per recuperare la vista: se il dio ci vede, ricchezza e benessere saranno finalmente agio di tutti. Peccato però che se tutti possono avere tutto senza sforzo, chi più farà la fatica di lavorare? (consigliamo la lettura della sempre attuale Favola delle api di Mandeville)
Il problema allora non è neanche la distribuzione in sé. Il 17 luglio 1996 si poteva leggere sul «Corriere della Sera»:
Se i 385 supericchi domani decidessero di devolvere le proprie ricchezze all’umanità, guadagnerebbero certamente il Paradiso (nonché il plauso dell’Onu) ma non risolverebbero i problemi del pianeta. In particolare non cambierebbero un sistema economico che continua – è innegabile – a creare una “sottoclasse” mondiale.
Ed ecco il fatto. Non si tratta tanto di ricchezza ma di potere. Cioè di decidere ciò che si può e ciò che non si può. Giocare a fare il padre eterno, insomma.

Foto di scena ©Franco Guardascione
Non è un caso allora se nella sua recente messa in scena del testo aristofaneo, la compagnia Archivio Zeta innesti in Pluto una riflessione su capitalismo e comunismo (secondo atto), con l’ingresso in scena di niente meno che Karl Marx; e sui pesanti strascichi di questo binomio (terzo e ultimo atto), con le voci in absentia dell’operosa comunità cinese di Prato.
Stiamo parlando di Plutocrazia, ultima produzione e ultimo spettacolo della fortunata stagione 2016/2017 del Teatro Metastasio di Prato (anche se l’assenza di Claudio Morganti – inizialmente annunciato – ci pare molto grave).
Nel piccolo palco del Magnolfi la scena è ingombra di scaloni che montano verso l’alto: eccola lì, chiara, evidente, l’ascesa sociale cui tutti puntano. Sul gradino più basso, in proscenio, troviamo il povero dio cieco (Enrica Sangiovanni), che si muove a tentoni. Poco più in alto, alle sue spalle, ché non se la passano certo meglio, Cremilo (Gianluca Guidotti) e il suo servo Carione (Ciro Masella).

Foto di scena ©Franco Guardascione
Fanno la commedia Archivio Zeta, la fanno con gran lazzi e sberleffi, canticchiano, mugolano, berciano, gracchiano, squittiscono, sacramentano nella ricchissima musicalità della traduzione in endecasillabi di Federico Condello. Quand’ecco che il Pluto si incrina: trottante e monotono, giunge un borbottio meccanico, industriale, poco a poco sempre più preciso: è il suono di una macchina da cucire.
Su queste inquietanti note di modernità entrerà dal fondo della scena Marx. Il suo spettro. Grottesco, buffone, obsoleto. Che al momento del confronto con Penia, la povertà, farà la stessa misera figura dello smanioso e avido Cremilo. Le macchine da cucire, nel loro profilo curvo, sembrano allora suggerire due C, di segno opposto ma complementari: Comunismo e Capitalismo. Come scrive Massimo Fini:
Liberalismo e marxismo (Destra e Sinistra), nelle loro varie declinazioni, radicali o riformiste, […] sono entrambi modernisti, illuministi, progressisti, ottimisti, razionalisti, materialisti, economicisti, entrambi hanno il mito del lavoro e sono industrialismi convinti che l’industria e la tecnica produrranno una tale cornucopia di beni da rendere felici tutti gli uomini (Marx) o, più realisticamente per i liberali, il maggior numero possibile. […] Sono come due arcate di un ponte che, apparentemente opponendosi, si sono sostenute a vicenda per due secoli.
La povertà, invece, col suo stretto pragmatismo ridimensiona tutti gli uomini e la loro smania di giocare a far l’onnipotente (si pensi a Trump che ritira gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sulle emissioni, per sostenere l’industria USA).

Foto di scena ©Franco Guardascione
Ed è proprio sul tema del lavoro che si chiuderà Plutocrazia. Prima con le mosse di Penia che ricopre l’intera gradinata in scena di cappotti scuri sulle note klezmer della sinfonia 1 di Mahler, in inquietante rievocazione dell’immaginario ebreo (Olocausto? Finanzieri?). Dappoi con la rievocazione del meraviglioso articolo di Parise del ‘74 sulla povertà (leggi qui). Infine, con la videoproiezione dei volti di alcuni pratesi (coinvolti in un laboratorio di tre mesi «a partire dalla ricerca VENDERE E COMPRARE – processi di mobilità sociale dei cinesi a Prato») in un mash-up di interviste “differite” all’invisibile e invisa comunità cinese locale, controprodotto di questa perversione contemporanea chiamata «comunismo capitalista». Una sorta di rinnovato coro greco in salsa post-drammatica.
È indubbio che Plutocrazia imbastisca un’acuta riflessione sul nostro tempo così legato com’è al complesso brogliaccio dell’economia; tuttavia l’impressione è che non sempre gli intrecci tentati restituiscano il ricamo desiderato. La rilettura di Aristofane è giustamente ambiziosa e raffinata ma in settanta minuti non può sostenere così tante questioni senza sdrucirsi qua e là.
Masella, vulcanico, sostiene e colora l’immaginario aristofaneo imbastardendolo di sporcature, eccessi e trivialità, come l’originale richiede, eppure a volte, soprattutto là dove la drammaturgia vira verso la denuncia socio-politica, la caricatura offusca il segno; così, di converso la pulizia di Guidotti e Sangiovanni raffredda la commedia nei suoi accessi ludici, mentre ben tratteggia le lucide stoccate contro l’economia produttiva. Da ultimo la questione del distretto industriale cinese di Prato, la presenza del video, delle interviste recitate, seppur concettualmente coerenti, appaiono un surplus che mina la compattezza dello spettacolo.
A nostro avviso il momento più prezioso si raccoglie attorno all’ingresso di Penia e a quell’affascinante e laconica stratificazione di cappotti. La crescita è una follia mortuaria.

Foto di scena ©Franco Guardascione
Il vero dramma non è la ricchezza in sé e per sé, perché si può essere ricchi di qualunque cosa, ma è la brama di denaro (che tutti desiderano e per il quale si compiono i delitti, sanguinosi e incruenti, più efferati). Perché il denaro è un’astrazione, ha solo valore nominale, non rappresenta una ricchezza in sé, non vale per ciò che è ma per ciò che può («potere»): è tutto spostato sul futuro, ma di fatto non vale un bel nulla. Il denaro è l’illusione dell’eterno potenziale. È pura tautologia. Una droga cui tutti ci siamo assuefatti. Per questo ha raggiunto livelli così folli. Sempre Fini:
Se prendo un individuo singolo e lo privo di tutto il denaro costui, in una società strutturata come la nostra a economia monetaria, muore di fame, ma se prendo tutto il denaro del mondo e lo butto nel cesso l’umanità vive lo stesso. Il denaro non aumenta di nulla la ricchezza del mondo, perché può acquistare unicamente ciò che c’è già, può trasferire solo la titolarità della proprietà delle cose. Può spostare ricchezza, non è esso stesso ricchezza.

Foto di scena ©Franco Guardascione
Bisogna allora ridimensionare innanzitutto la nostra smania, la nostra avidità, il nostro desiderio di volere. Ritornare a noi. A ciò che ci è veramente necessario. Se vituperiamo tanto l’economia, in fondo, è solo perché fa da specchio alla nostra stessa ingordigia. Ecco perché non ne vogliamo sapere. O come giustamente recitano Archivio Zeta:
CREMILO E allora perché fai schifo a tutti?
PENIA Perché li miglioro.