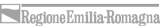Ci si può immaginare quello che immagine non ha? Note su il volto di archivio zeta
Michele Pascarella | 09/09/2021 | Gagarin orbite culturali
Nel 1735 Alexander Baumgarten, in un suo breve trattato pre-Aesthetica, ragiona sulle idee, distinguendole tra noetà (quelle “pensate”) e aisthetà (quelle “sentite”), a loro volta suddivise in sensualia (le sensazioni percepite col corpo, qui e ora) e phantasmata (le “sensazioni assenti”, di cui resta traccia nella memoria o che sono prodotte dall’immaginazione).
È proprio lì, nella fessura tra sensualia e phantasmata, che si collocano le evanescenti, smarginanti figure de Il volto di Archivio Zeta.
Smarginanti perché stanno in un territorio altro, terzo, che non è né circoscrivibile unicamente nell’alveo del percepito né relegabile in un più o meno fumoso altrove.
Ne Il volto vi sono tutti gli elementi che nel comune sentire denotano un «buono spettacolo»: un referente letterario alto (in questo caso L’idiota di Dostoevskij, autore a cui la Compagnia nel bicentenario della nascita, 1821-2021, ha dedicato il progetto triennale Topografia Dostoevskij 2019/2021, della cui apertura scrivemmo qui), un solido lavoro d’attore, raffinati costumi la cui realizzazione (a cura di les libellules Studio) è frutto di sapiente cura dei materiali e suggestioni cinematografiche e pittoriche, il colto nutrirsi di saperi molteplici non unicamente afferenti all’alveo teatrale, la millimetrica sapienza topografica, dunque etimologicamente di «scrittura del luogo», nel comporre gli sguardi degli spettatori chiamati a errare negli spazi esterni e attigui a Villa Aldini, alle porte di Bologna, area che da alcuni mesi -e ci auguriamo per tanto tempo ancora- Archivio Zeta sta portando a nuova vita (si veda qui il calendario passato e futuro delle molte nutrienti e diversificate proposte).
Tutto ciò è, in piena evidenza e con un minimo di curiosità, percepibile.

Vien fatto pensare, altresì, che vi sia un’altra possibile lettura dell’azione estetica, dunque conoscitiva, a cui Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni e cum panis chiamano lo spettatore.
Un corpo a corpo con l’immagine.
O meglio: con la percezione.
O ancora meglio: con la (im)possibilità della rappresentazione.
Non sono, ça va sans dire, faccende per specialisti. Pleonastico ricordare quanto noi, tutti noi, si sia ininterrottamente invasi dalle immagini, immersi in un fiume che, consapevolmente o meno, ci costituisce. Quanto ciò che percepiamo sia solitamente -e convintamente- sovrapposto alla nostra idea di realtà (le recenti infervorate discussioni pro e contro Green Pass et similia ne sono una lampante riprova). Quanto, ancora, la progressiva iper-virtualizzazione di molte delle nostre esperienze quotidiane renda indifferibile per ciascuno (che si interessi od occupi, o meno, di arte) porsi fonde domande su quanto la rappresentazione del mondo che ci attraversa sia -e qui usiamo un aggettivo che fa tremare i polsi per quanto è smisurato- reale.
Archivio Zeta pone la questione nel terreno che gli è proprio: quello dell’arte.
E lo fa con l’intelligenza di non chiuderla in definizioni perentorie.
E lo fa con la perizia di equilibristi: in bilico tra il qui e l’altrove, potremmo dire parafrasando il Baumgarten citato in apertura di queste poche righe.
Che poi è, forse, ciò che l’arte non dottrinale dovrebbe sempre fare.
La prima cosa che colpisce della sapienza antica, da malinconici filosofi montanari, di questi artisti, è la misura.
La seconda è il rispetto.
Innanzitutto, per i materiali.
Guardano a Dostoevskij con la partecipe deferenza con cui un contadino scruta il cielo la sera, usano le sue parole come mattoni per circondare un vuoto, utensili per circoscrivere l’indicibile.

«Ci si può immaginare quello che immagine non ha?» chiede e ci chiede Enrica Sangiovanni in chiusura della scena forse più folgorante dello spettacolo, agita nella Rotonda della Madonna del Monte, chiesa sconsacrata di fondazione benedettina edificata intorno al 1100, circondata da affreschi di cui rimangono frammenti di volti e figure e accompagnata dallo struggente Concerto in mi minore per flauto dolce e flauto traverso di G. Ph. Telemann (qui una esecuzione).
Davanti a lei, quasi un agnello sacrificale sull’altare del senso comune, Alessandro Vuozzo in figura del corpo del Cristo morto nella tomba di Hans Holbein il Giovane del 1521, da cui lo stesso Dostoevskij fu ossessionato tanto da farne oggetto di reiterata discussione da parte dei personaggi proprio de L’idiota, a cominciare dal principe Myškin.

In questo celeberrimo dipinto il corpo di Cristo è ritratto prima della resurrezione. Il volto, le mani e i piedi sono in un primo stadio di putrefazione. Il corpo, disteso, appare in più punti emaciato, con la bocca e gli occhi semiaperti. È noto come Holbein abbia utilizzato il corpo di un morto affogato e ripescato nel Reno a modello per quest’opera.
È un’immagine che con forza finanche macabra (pro)pone la carnalità di Cristo come elemento radicalmente iconoclasta, quanto di più distante dall’auto-consolatoria negazione del corpo e dei suoi impulsi su cui la Chiesa ha invece fondato (gran) parte della propria dottrina, sæcula sæculorum.
In questo senso Il volto può essere inteso come (ma non ridotto a) una tagliente domanda posta alla nostra spesso sopita relazione con il Sacro.
Tanto altro si potrebbe e forse dovrebbe dire sull’azione culturale di Archivio Zeta (molti sono i progetti, impossibili da riassumere in queste poche righe), sulla loro rigorosa e visionaria ricerca artistica che si nutre di mondo -non solo di accademia- concependo e realizzando opere che si pongono non tanto come rilettura del reale, quanto come un suo peculiare frammento.
–
Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini.
[ Guy Debord ]
–
MICHELE PASCARELLA