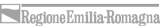Archivio Zeta, l’uomo e il teatro
Matteo Brighenti | 08/05/2016 | PAC
MATTEO BRIGHENTI | La storia di Archivio Zeta è legata al Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa, nell’Appennino tosco-emiliano, come lo sono le parole alla punteggiatura. Dal 2003 del più grande sacrario di vittime tedesche della Seconda Guerra Mondiale hanno fatto prima una “agorà tragica” e poi, recentemente, un “teatro di marte” con Gli ultimi giorni dell’umanità – macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus. Gli ampi luoghi aperti si addicono a Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, come confermano anche le creazioni per VolterraTeatro La Ferita/Logos-Rapsodia per Volterra e Pilade/Pasolini, quest’ultima replicata in forma di maratona anche nella città di Bologna.
Per questo il “Dittico sull’essere umano” proposto da Elsinor alla Limonaia di Villa Strozzi e al Teatro Cantiere Florida (dal 27 al 30 aprile scorsi) ci è parso oltremodo importante, nel merito più generale di averli riportati a Firenze, da cui mancavano almeno da dicembre 2000: ci ha permesso di osservare come la compagnia riesca a declinare la sua acquisita spazialità dentro il rettangolo del palcoscenico, cioè di considerare come un teatro che ha espanso i confini del suo accadere, facendo di necessità una scelta, possa restringersi entro le pareti di una sala. Renzo Francabandera ha recensito per PAC entrambi gli spettacoli: al suo sguardo rimandiamo per il racconto e l’analisi dei due spettacoli presentati, L’uomo e le cose ed Edipo re.
Guidotti e Sangiovanni parlano a passo di marcia: tutto quello che dicono deve essere compreso, ogni singolo fiato è essenziale per far correre la frase dritta e spedita come un proiettile dal ragionamento al senso. Le parole sono calce, ampliano lo spazio d’azione, ne forzano il raggio a descrivere il tragitto del pensiero, rivelato prima a sé e poi agli altri. E come le maschere Nō hanno una funzione mediatrice, servono a richiamare entità superiori e a costruire un punto di incontro tra il mito e la storia, in un procedere a ritroso, dagli effetti alle cause, dalle conseguenze all’origine. Tiresia è cieco, il copione invece è muto: se per profetare bisogna trovare la luce dentro i propri occhi, per Archivio Zeta per recitare bisogna dare voce ai propri silenzi.
In scena, infatti, i due hanno una fermezza ieratica, quasi statuaria. I movimenti sono estremamente stilizzati e ridotti all’essenziale. Le braccia e le gambe disegnano distanze e profondità che vanno a ricomporsi quando si ritrovano, e capita spesso, di fronte, su una scacchiera di potere e fede, notte e sangue. È un teatro questo della riflessione, rinuncia all’interpretazione in favore della dimostrazione di una tesi, cui segue sempre un’antitesi, in una spirale che puntella la partitura attorale e si avvita fino alla fine, ovvero finché una non prevarica sull’altra.

L’uomo e le cose @ Franco Guardascione
Potrebbe venire un terremoto e sarebbero ancora là, perché partecipano di qualcosa (rito, energia, comunità) che è prima di loro e continuerà anche dopo. Violenza e precisione, il passaggio dall’ordinario al sorprendente non è ghiribizzo, ma espressione risolta. Nel loro mondo c’è più maestà e passione, intensità, visione, che tenerezza. Non (si) commuovono, vedono, ricordano, meditano, sparano e colpiscono il segno, come quel fucile di cui scriveva Emily Dickinson: “la mia vita era rimasta – un fucile carico – negli angoli – finché un giorno il proprietario passò – identificò – e mi porto con sé”.
Gli spettatori, il coro/città, rimangono al buio: ormai abbiamo cessato di vedere e la vita è sempre più un’emergenza, un’incognita piena di trabocchetti, tesi dal denaro, dal potere, dalla sopraffazione. Così, Archivio Zeta ci sottopone a una critica poetica, ironica, talvolta risentita, la doppiezza degli dei (chiunque essi siano, il mercato, le ideologie, le paure) nel creare il cattivo e poi punirlo non cessa di suscitare la loro protesta. Vivono la crisi delle relazioni, del rispetto, della speranza, una crisi che però non si placa nell’adesione o nel rifiuto definitivo.
Il loro teatro, allora, è sospeso, c’è il sogno di un momento risolutivo, di riconciliazione e riunione, c’è la consapevolezza delle lacune degli insegnamenti tradizionali e dell’imprescindibilità del dolore odierno, c’è anche il suggerimento che, comunque, la scena decisiva dell’uomo è solo e sempre nel presente della sua esistenza, fuori dal tempo tanto quanto è nel tempo.
L’artista sente e vede per tutti, dal suo punto di vista defilato eppure centrale. Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, più antichi degli antichi e più moderni dei moderni, colgono l’umanità sul nascere, in tutta la sua ambiguità, complessità e rara felicità. Tutto sta nell’incorniciare il flusso della realtà per fissarlo liricamente e rivelarne il segreto ossia che “il male è troppo forte per poterlo sopportare”.
La parola in scena è tutt’uno con quel segreto. Il destino di Edipo è scritto nel bastone di Tiresia, legno nodoso di cui sono fatte anche le assi del palcoscenico. Incontrarci serve a farci capire che siamo meno soli e diversi di quanto crediamo.
Per approndire, leggi anche:
Manuela Margagliotta, “La ricerca senza fine: Dittico sull’essere umano di Archivio Zeta”, su [paper street].