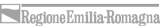MATTEO BRIGHENTI | La città franata risorge pietra su pietra. Il cuore di Volterra batte in Piazza dei Priori al suono di sassi bianchi e levigati, passi di un distacco che si colma di speranza: affrontare la tragedia dei crolli delle mura medievali rendendo visibile, umano, sanabile lo squarcio dentro lo sguardo di ognuno. La XXVIII edizione di VolterraTeatro ha riflettuto sull’idea di “Ferita” e il progetto di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni di Archivio Zeta, La Ferita / Logos – Rapsodia per Volterra, ha tracciato geometrie di rinascita annodando i luoghi-simbolo del borgo con 20 chilometri di nastro rosso.
Sassi contro la terra, sassi contro altri sassi. Lasciano tracce, polvere sulle mani, detriti. La caduta è una miriade di frammenti. Per questo, scelgo di seguire l’azione stando su una piattaforma multi-mediale: il cellulare per tweettare e fotografare, la radio per collegarmi al Radio Walk Show (Urban Experience) di Carlo Infante, una conversazione itinerante che moltiplica viste e visioni. Insieme a me altri colleghi di Rete critica raccolgono la sfida di farsi causa ed effetto, di stare dentro e intorno, tra lo spazio de La Ferita e quello evocato in cuffia da Infante. Le righe tra cui state leggendo sono il triplo salto verbale che ricompone tutto questo nel dopo, solitario e freddo, dello schermo di un computer.
Il filo rosso comincia a dipanarsi dal Carcere al termine di Santo Genet della Compagnia della Fortezza. Intanto, in Piazza dei Priori una Babele di legami, un coro di stoffa, una trama di separazioni condivise ci unisce per le mani e le gambe. Dal Palazzo del Comune scende un lungo ritaglio rosso che incrocia la ragnatela giù, tra la gente, e poi su, tra le finestre di fronte. Un drone telecomandato sorveglia dall’alto ogni più piccolo movimento. Arriva il corteo, riunito in un sol battito dei sassi. Silenzio. Risuonano le parole di Giordano Bruno, il frate renitente all’abiura degli infiniti mondi possibili. Siamo nel rogo, perché siamo fiamme, il rosso della stoffa è il sangue versato dalle pietre che hanno scolpita tutta la sapienza di questa rocca umana. Il nodo è stretto. La ferita è un passato che rimane, resta addosso. Per proseguire, allora, bisogna tagliare, separare, spartire. L’unione è nella forza delle braccia, non nella lunghezza della stoffa.
Il nastro a brandelli ci lega al cammino in direzione di Piazza dei Fornelli, là dove il maltempo si è abbattuto quest’inverno, aprendosi un varco di 30 metri nell’esistenza, fino ad allora sicura, di Volterra. La ferita è sotto i piedi, intrecciata nei fili lasciati a terra, e davanti agli occhi, sul muro dove deponiamo i sassi bianchi come uova di una covata cittadina che schiuda nuova solidità. Sullo sfondo, la gru della ricostruzione, che qui ti segue ovunque, come l’orizzonte, come il respiro.
Uno squillo di trombe omaggia il sole e introduce il pensiero di Leonardo Da Vinci. Non piove. No. Oggi cadono solo parole forti come pietre. Ogni frase è come se fosse la più importante e quella che segue non si sapesse o non esistesse proprio: conta solo il momento presente, l’istante, ora, prima e poi non esistono.
La Ferita, quindi, non è semplicemente teatro itinerante, performance, o visita drammatizzata, è un rito sacro, è trasmissione, salvaguardia, è mantenere accesa una testimonianza che se si spegne è persa, come il fuoco prima della scoperta delle pietre focaie. Lo spettacolo diventa tutto, Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni, i cittadini del laboratorio teatrale, il cielo, le case, le strade e i nomi che si portano dietro mute, il pubblico che si fa pagina bianca su cui scrivere e riscrivere ancora. Siamo quello che abbiamo dimostrato di essere, come gli attori-detenuti della Compagnia della Fortezza quando, nel finale di Santo Genet, portano in processione le loro sagome di cartapesta: non abbiamo altro che noi stessi per rappresentare la nostra Storia.
La stazione ultima del progetto di Archivio Zeta è l’antico teatro romano. Può una rovina, una maceria, essere la base su cui ricostruire i legami tra le persone e i luoghi che abitano? Quando le pietre sono state vive lo rimangono, a dispetto del tempo, anche se mancano di più parti, in più punti, continuano a parlare l’alfabeto per intero. Soprattutto quelle di un teatro che hanno sorretto migliaia di storie, vere o presunte. Si leva alto l’avvertimento di Vincenzo Consolo: lo sfascio dei costumi non deve farci chinare il capo, deve darci forza. La ferita è là, negli occhi di ogni giorno. Dobbiamo cercarla, farla nostra, accoglierla. “Muro che crolla, muro che crolla.” Rullo di tamburi. Cade anche l’ultimo ostacolo, la quarta parete tra il presente e il futuro. Adesso andiamo in scena. Sul palcoscenico della vita.
Per ripercorrere tutto il Festival qui il Visual Storytelling a cura di Simone Pacini / fattiditeatro.