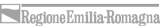Archivio Zeta: Pilade nella fabbrica di sale
Massimo Marino | 14/07/2015 | Corriere di Bologna / BOblog

Archivio Zeta: Pilade nella fabbrica di sale
Una fabbrica bianca, cumuli cumuli di sale. Pier Paolo Pasolini e il suo grido contro una modernità che seduce e distrugge. Archivio Zeta, gli operai della Smith Bits, la chiusura, 193 minacce di licenziamento. Il festival Volterrateatro. Un gruppo di donne venute da Bologna che danno corpo alle nuove deità della città razionale, di Atena, dove lavoro, divertimento, intelligenza sono contemperate, disponibili, comperate. Dimenticando i grovigli dell’umano. Un pubblico assiepato, settecento e più persone in due recite a Saline di Volterra. Uno spettacolo bellissimo, Pilade / Campo dei rivoluzionari di Archivio Zeta.
La compagnia ormai bolognese di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti lo ha voluto fortemente, questo lavoro. Lo ha preparato con i volterrani che l’anno scorso avevano partecipato alla Ferita, azione di strada che si snodava per Volterra con un lunghissimo filo rosso per ricordare il crollo delle mura della città. In quell’occasione aveva lavorato con molti cittadini, che hanno voluto continuare l’esperienza. È tornato, Archivio Zeta, quest’anno, e ha tenuto un seminario un giorno alla settimana per mesi. Ha incontrato gli operai della Smith Bits. Per questo finale ha portato nell’antica capitale dell’Etruria il gruppo bolognese che lo segue nelle altre parti dei progetto Pilade, quattro lavori in luoghi diversi per interpretare la pièce di Pasolini (Monte Sole, fatto in primavera, e i prossimi episodi al Cimitero militare germanico della Futa e a villa Aldini, per una ricomposizione, a Bologna, il 2 novembre, anniversario della morte dello scrittore. Spazio e parola sono gli elementi, parola nello spazio, in spazi reali, portata da corpi, parola che scava mentre l’immagine crea associazioni, rimandi, spaesamenti e la presenza convoglia in elettricità emotiva e intellettuale gli elementi preesistenti.

ph. Stefano Vaja
Pioveva sale dall’alto, nella camera della fabbrica di minerale. E prima ancora donne e ragazzi chiamavano Pilade dagli angoli della struttura razionalistica della fabbrica in produzione, illuminata sullo sfondo. Un uomo antico, Pilade, camicia contadina, una coperta per difendersi dal freddo. Figure nere sui cumuli di sale, nel capannone bianco disegnato in anni lontani come il ventre di una balena da Pier Luigi Nervi. Parole amplificate, lievemente deformate, echeggianti, lontane e pervasive, come un messaggio da spazi o tempi siderali, con suoni (di Patrizio Barontini), insinuanti, con esplosioni di cantate barocche. Atena, di rosso vestito e bianco mantello, armata di lancia, l’espressione dura di chi comanda, riconcilia la città con i suoi dei antichi. Richiama le Eumenidi dalla campagna, invade con festa di ramoscelli di ulivi e grandi bandiere bianche lo spazio candido, di sale, di cristalli, di arsura e polvere. Festa, di un nuovo patto di sviluppo. Parole di Pasolini, che a metà degli anni sessanta raccontava i nostri giorni già con la lucidità di Petrolio, lo spettacolo dei tutti felici, l’oblio, l’apparente rimozione degli antichi umani grovigli.

ph. Franco Guarnascione
Festa di sangue nell’abbacinante candore, tra piogge improvvise di sale sui cumuli, sugli abiti dei neri coristi, i partigiani delle montagne: i portatori di bandiera bianca, sotto la maglia nera ne hanno una chiara, con sopra la scritta: no ai licenziamenti della Smith Bits. 193, impariamo, il numero scritto sulla schiena, quando l’esterno li risucchia via dalla scena, scarti di quella città radiosa promessa da Atena. Commozione. Rabbia. Silenzio attonito del pubblico. È in scena anche un gruppo di loro, gli operai minacciati di licenziamento, 193, un’apocalisse in una piccola comunità
Retorica. La dea promette la conciliazione, al felicità, e tutti tradiscono lo spirito delle montagne, i partigiani abbandonano le cime, contenti di dimenticare antiche tristezza, arcaiche povertà. La scena popolata si spoglia. Pilade nelel spire del mantello di Atena. Poi solo lui resta, con il pugno alzato di un’inane, necessaria resistenza, che richiude, il pugno, con il braccio, per coprirsi gli occhi, al vista della fabbrica seducente, della città illuminata. La voce di Pasolini dice il suo poema rivolto ai senza storia, che popolano i caseggiati infiniti, Le ceneri di Gramsci, la sconfitta, l’incapacità, la debolezza del pensiero di fronte alla vita.

ph. Stefano Vaja

ph. Stefano Vaja
La parola, qui, è sovrana, tra i riverberi delle immagini: indagatrice di scontri, di nodi irrisolti, gli stessi che ci portiamo sempre dietro, dentro, la festa, il dolore, il moderno, luccicante, l’antico, gli scarti, gli esseri umani ridotti a scorie dello sviluppo, sale. Una bambina in lunga veste rossa segna questa tappa del testo, come le altre, con sguardo lontano, silente, come una domanda senza risposta. Era già qui, tra rocche montane, cimiteri di campagna, aspri luoghi di zolfo e di morte. La storia si scrive con i piedi, avanzando, scoprendo la terra, fondando città, distruggendo, ritirandosi nelle serre lontane, rimpiangendo, travolgendo, rivolgendo domande alla democrazia. Le parole del vecchio poeta assassinato quarant’anni fa mai suonarono più attuali. Stringenti. Nell’indignazione, nella profezia, nella poesia sussurrata da corpi di ogni età, bambine, donne mature o giovani, uomini forti, ragazzi, operai in scena, barbe che sembrano dubitare del candore della bandiera che ostentano. Dolore, rabbia, memoria. Uno spettacolo bellissimo, un capolavoro di umanità, accolto da ovazioni per minuti e minuti, di un pubblico che non vuole lasciare quella polvere di sale che dappertutto si deposita, tutto copre, brucia.

ph. Stefano Vaja

ph. Stefano Vaja
La fotografia di apertura è di Stefano Vaja