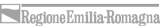Nelle pieghe della furia, del cordoglio, della pietà: Iliade i fiumi parlano di Archivio Zeta
Massimo Marino | 03/05/2014 | Corriere di Bologna / BOblog

Nelle pieghe della furia, del cordoglio, della pietà: Iliade i fiumi parlano di Archivio Zeta
C’è qualcosa di profondamente antico negli spettacoli di Archivio Zeta. E di contemporaneo senza fronzoli, fuori dalle etichette. Vi agisce una sapienza teatrale che ha respirato Brecht, che è passata alla scuola strutturalista di Luca Ronconi e a quella essenziale di Jean-Marie Straub, che ha meditato il “teatro di parola” di Pasolini, ed è diventata lingua personalissima, ricca di echi ma anche di illuminazioni impreviste. L’Iliade vista nel piccolo spazio dell’Oratorio di san Filippo Neri a Bologna, per un ciclo sulla “Pietà” curato dal grecista Federico Condello e ospitato nella rassegna del Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, lo dimostra in modo inequivocabile.
Qui siamo lontani dagli allestimenti a cielo aperto, in luoghi carichi di risonanza come il Cimitero militare germanico della Futa o come il teatro romano di Fiesole o quello greco di Segesta. Il palcoscenico ridotto costringe a economie di spostamenti, a sintesi di mezzi che nulla tolgono alla costruzione dei lavori. Bastano un personaggio che domini dall’alto e uno che si collochi più in basso, un cambiamento di posizione per indossare un altro carattere, un esibire una corazza, sottoporsi al basto di redini, mostrare una lancia e un cerchio che raffigura uno scudo, ed ecco che si viene precipitati nel grande teatro e nell’atrocità di una lotta senza quartiere, dove le vite sono azzardo nelle mani della forza o degli dei, nel gioco spietato dell’ira violenta, della guerra. È sufficiente un cambio di luci in tonalità irreali, troppo cariche o estremamente diafane, per proiettare, complice la musica ora epica ora minimale ora incalzante (con brani di Iannis Xenakis e di Beethoven) per proiettare nel tempo mitico dell’epos, in una lotta senza esclusione di colpi che porterà al terrore e alla pietà, intesa nel senso antico di cordoglio che nasce da una profonda immedesimazione.

Si inizia, in questa versione ridotta rispetto allo spettacolo del 2009, con Efesto che su un metallico podio rosso fabbrica le armi per Achille, come riconoscenza della protezione accordatagli dalle abitanti del mare e quindi dalla madre dell’eroe, Teti. Alfredo Puccetti dà al dio toni insieme colloquiali e da antica filastrocca contadina, in uno scandire di martello che introduce nell’allucinato clima di guerra. Saranno poi Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti (anche registi) gli “aedi” (come sono denominati nel programma di sala) dei momenti della prova delle armi, del duello tra Achille e Ettore, della spietata uccisione del troiano. Introducono, con semplici spostamenti, cambiamenti di fronte nella scena, altri personaggi: il cavallo divino Xanto, che pronuncia sconsolati presagi, la dea Atena che illude Ettore di contare su aiuti terreni e di poter resistere alla furia del Pelide. Basta poi un disequilibrio della lunga asta, che funziona anche da bilancia di una imperscrutabile giustizia, per far pendere le sorti da una parte o dall’altra, seguendo il fato, l’azzardo, lo scatenarsi della ferocia.
Per Ettore, come da copione, non c’è salvezza. Solo il suo corpo, dopo la morte, avrà requie di sepoltura, perché Achille si intenerirà, dopo notte agitata, alle parole del vecchio padre Priamo, che tanto gli ricorda il proprio genitore e lo sprofonda nella riflessione su come il destino avrebbe potuto intrecciarsi in modo opposto. È Luciano Ardiccioni a incarnare il dolore dell’anziano re, immobile come statua seduta, mobilissimo nella voce cantilenante come magica implorazione.

In questo spettacolo la parola, nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti (con inserti di Simone Weil e Cesare Pavese), è, come dice il sottotitolo, I fiumi parlano, corrente che prende, avvolge, trasporta, travolge, creando un corrispettivo della furia fisica narrata dal poeta. Gli “aedi” lavorano a straniare, a staccare le parole con metodo ronconiano, rendendole guizzanti, cose vive, pietre, armi, attese, vuoti difficilmente riempibili, domande di senso. Lo stile di questa originalissima compagnia – una delle più potenti che ci è dato vedere in anni poco generosi di novità vere –, riconoscendosi nei maestri, diventa peculiarissimo, capace di attingere momenti fortemente personali, nei quali la distanza narrativa o raziocinante si mescola con lo stupore favolistico, popolare, la saggezza vira improvvisamente nella follia umana, la violenza si raffredda nella meditazione per poi riesplodere bruciante. Perfino un certo pathos quasi ottocentesco della dizione risuona come campana di bronzo ben temperato, come tentativo (riuscitissimo) di trovare la furia, l’abbandono, il cordoglio, l’afflizione efferata di arcaica e ancora attuale ferocia. Così, alla fine, agli applausi entusiasti, questi attori sembrano antichi pastori che hanno narrato una storia universale davanti ai bagliori stupefacenti della fiamma di un fuoco nella notte più buia.


Le foto in bianco e nero, scattate nel teatro romano di Fiesole, sono di Franco Guardascione