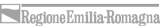L’Incanto della Montagna Magica
Marino Freschi | 31/10/2024 | Doppiozero
Il 10 aprile 1912 alle ore 12.06 il Titanic salpò dall’Ormeggio 44 di Southampton. La notte tra il 14 e 15 affondò. Non sappiamo che cosa avesse pensato Hans Castorp, «un giovane uomo come tanti altri», appena laureato in Ingegneria navale ad Amburgo e già assunto dai cantieri navali della Ditta Tunder & Wilms. Stava viaggiando per una breve vacanza di tre settimane verso Davos-Platz da suo cugino Joachim Ziemssen, ricoverato al sanatorio Berghof. «Accanto a lui, sulla panca, era posato un volume in brossura dal titolo Ocean Steamships su cui all’inizio del viaggio si era ogni tanto concentrato, ma che ora giaceva negletto». Hans non pareva particolarmente interessato all’argomento, poiché «il giovane non era ancora saldamente radicato nella vita».
Il romanzo di Thomas Mann, Der Zauberberg, lo conosciamo come La Montagna Incantata (così in due precedenti traduzioni, dove “incantata” partecipa della nobile accezione ariostesca) e dal 2011 quale La Montagna Magica nell’affidabile traduzione di Renata Colorni e con l’attenta cura di Luca Crescenzi per «I Meridiani». L’originale venne pubblicato nel 1924, ma era stato iniziato proprio nel 1912, ma del Titanic non c’è traccia nel romanzo che venne interrotto e ripreso dopo la Grande Guerra e concluso appunto cento anni fa. Eppure l’immagine del titanico transatlantico potrebbe ben fungere da metafora di un’epoca, di un mondo che affondava, irrimediabilmente, irreversibilmente.
Oppure no, nel senso che proprio il romanzo redime e salva, raccontandolo, quel mondo, quella Belle époque, quella varia comunità internazionale che, malata e morbosa, si era radunata un’ultima volta, in un sabba satirico e disperato in quell’elegante sanatorio svizzero in cima a un monte, dove spazio e tempo erano sospesi, e dove lo stesso autore – che a quel mondo partecipava e apparteneva socialmente e culturalmente – si soffermò per qualche settimana in visita alla moglie ricoverata. Per anni, ancorché interrompendo la scrittura, Mann restò radicato a quell’ambiente, a quella cultura decadente, morente, raffinata, meravigliosa, estenuata, incantata appunto. Nella pausa della scrittura avvenne di tutto, dalla Grande Guerra alla stesura del saggio-monstre, Considerazioni di un impolitico, che spiegano a posteriori la dialettica tra i due maestri (o falsi maestri) del giovane Hans, Lodovico Settembrini, mazziniano, carducciano, massone, illuminista, progressista e il gesuita Leo Naphta, ebreo convertito, totalitarista, convinto della fragilità ideologica della modernità e della fallacia dell’ideale del progresso (figura mutuata da György Lukács, appena ‘convertito’ al marxismo).
La diatriba intellettuale diventa un fascinoso interludio filosofico all’interno del romanzo, che conosce una miriade di sfaccettature, che culminano nell’incontro di Hans con Madame Chauchat, raffigurazione del femmineo che incanta il protagonista – e il suo autore. La giovane donna caucasica, androgina ricorda a Hans il suo compagno di scuola, Přibislav Hippe. In un sinfonico accordo erotico – tutto in francese – torna così il manniano, sotterraneo leitmotiv dell’omofilia, il fil rouge che percorre l’intera scrittura manniana, l’intera sua vita.
Nel romanzo – autentica opera-mondo –, Mann, quasi cinquantenne, raffigura nel capitolo più intenso della narrazione – Neve – un’esperienza che traversa la fascinazione della morte per giungere a una rivelazione che innalza la Montagna Incantata a “romanzo di iniziazione”. Quel che nel 1912 doveva essere una novella, una short story, un pendant satirico alla Morte a Venezia, negli anni dell’attraversamento della guerra mondiale, – che gli aveva fornito il finale con Hans che parte volontario per il fronte –, si era trasformato in un testamento spirituale.

Il significato ‘iniziatico’, raccontato da Mann in una lezione a Princeton il 10 maggio 1939, costituisce una delle più valide chiavi per avvicinarsi al senso intimo del romanzo, in cui il protagonista: «impara a comprendere che ogni sanità superiore dev’essere passata attraverso la profonda esperienza della malattia e della morte, così come la conoscenza del peccato è premessa necessaria della redenzione. […] Questa concezione della malattia e della morte come passaggio obbligato sulla via della coscienza, della salute e della vita fa della Montagna incantata un romanzo di iniziazione». Questa intuizione viene approfondita e confermata dalla scoperta di aver scritto non solo un romanzo di formazione, un Bildungsroman, sulla scia di Goethe e precisamente del Wilhelm Meister con cui il romanzo di Mann presenta forti affinità, ma anche un racconto iniziatico. Entrambi i protagonisti sono giovani, ingenui, innocenti (e borghesi).
Per Castorp l’ascesa al monte, e il soggiorno per i mitici sette anni in cima alla montagna rievoca il mistero del Graal, e del Montserrat, che Goethe aveva evocato nel suo poemetto, incompiuto, I Misteri. Il simbolo del Graal suggerisce a Mann un’interpretazione che gli rievoca “The Quester Legend”. Il Quester è «colui che cerca e interroga, che percorre il cielo e l’inferno, che tiene testa al cielo e all’inferno e stringe un patto col mistero, con la malattia, col male, con la morte, con l’altro mondo, con l’occulto, con quel mondo che nella Montagna Incantata è detto “dubbio”, alla ricerca del “Graal”, cioè del supremo, del sapere, di conoscenza e iniziazione, della pietra filosofale, dell’aurum potabile, della pozione di vita». La conoscenza della morte, sfiorata da Hans nell’improvvisa nevicata, è cruciale nella sua peregrinazione sulla montagna, con la rivelazione del mistero della vita, così come nel Meister di Goethe vi era il messaggio sublime «Ricordati di vivere». E Castorp giunge alla svolta epocale della sua giovane vita ancora affascinato dalla morte, da quell’incantamento tardo-romantico, crepuscolare.
Quando finalmente si apre all’esperienza interiore di vita e morte, sceglie la vita, si scrolla di dosso il torpore che l’aveva afferrato insieme alla neve che l’aveva pericolosamente ricoperto. Sì, finalmente in lui risuona salvifico il richiamo della bontà, dell’amore, della Vita nova: «Voglio nel mio cuore serbarmi fedele alla morte ma anche ricordare con chiarezza che la fedeltà alla morte e a ciò che è stato, è solo malvagità e cupa voluttà e misantropia qualora essa determini il nostro pensare e ‘governare’. In nome della bontà e dell’amore, l’uomo non deve concedere alla morte il dominio sui propri pensieri. E con ciò mi sveglio… Perché con ciò ho concluso il mio sogno e sono giunto alla meta. […] Su, forza! Apri gli occhi! Ci sono le tue membra, le tue gambe, là nella neve! Chiama a raccolta le tue forze». Il finale di questa scena, quella centrale del romanzo, con l’esortazione anche tipograficamente messa in risalto (l’unica in corsivo in tutto il romanzo), è un capolavoro dell’ironia manniana. Il giovane raggiunge sano e salvo il sanatorio proprio all’ora di cena: «A cena si avventò sul cibo. Ciò che aveva sognato stava ormai svanendo. E ciò che aveva pensato, già quella sera stessa, cominciava a non capirlo più tanto bene».
Il racconto del giovane sul Berghof prosegue fino a quel finale drammatico per lui e per l’Europa tutta. La vecchia Europa si congedava per sempre con quel Donnerschlag, con quel metaforico tuono, per discendere, in uno stato sonnambolico – secondo la struggente e lucida analisi di Hermann Broch nella trilogia I sonnambuli del 1930-32 – nella catastrofe della storia (in cui pare che si trovi ancora), mannianamente nella ‘pianura’ della dura, cruenta realtà del conflitto mondiale, nell’abisso della violenza della guerra con cui finiva con la Belle Époque l’egemonia politico-culturale del vecchio continente. Il romanzo presentava uno spessore intellettuale e artistico significativo, il giovane Hans era l’avatar novecentesco del medievale Perceval-Parzival, il ‘puro folle’, della Queste del Graal (1225-1230), e malgrado il momento socialmente drammatico per la Germania, il messaggio nel 1924 venne accolto con favore, ma presto dimenticato.
L’«accrescimento alchimistico» di Hans Castorp, di cui narra Mann nella conferenza per gli studenti di Princeton, si compie durante il suo settennio sul magico monte con allusioni quasi nascoste a un messaggio tendenzialmente ermetico-alchemico. Ben presto l’autore cominciò a dubitare della salvezza della Repubblica, resa incerta in quel clima politico, sempre più fosco e violento. Si può pensare, infatti, che con l’avvento del nazismo la cultura tedesca dimenticò, in gran parte, se stessa: il romanzo rimase un immenso monumento, un incantato Zauberberg, una Montagna Magica quale un meraviglioso detrito morenico di una civiltà che affondava come il Titanic.
Solo la memoria non s’inabissa. E infatti proprio in Italia nel Cimitero Monumentale Germanico della Futa, dove sono sepolti 30683 soldati tedeschi (tutti fratelli minori di Hans Castorp) caduti sulla Linea Gotica nel 1944-1945, da alcune estati la Compagnia teatrale Archiviozeta di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni mette in scena La Montagna Incantata. Ambientazione suggestiva, sobria e perciò commovente, perfetta per quel «Weltfest des Todes», per quella «Festa universale della morte» con cui si chiude il romanzo nell’attesa improbabile, ma non impossibile, che possa «affiorare l’amore»: questa l’ultima parola del romanzo.