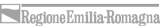Archivio Zeta sulla montagna incantata
Massimo Marino | 04/08/2022 | Doppiozero
Si sale, davvero si sale. Ci si isola dal mondo, dal caldo della pianura, con questo vento che accompagna il sole calante tra i monti. Il Cimitero militare germanico del Passo della Futa è davvero una strana montagna. Incantata, per le molte anime che contiene: quelle di più di trentamila soldati tedeschi – gli invasori – seppelliti sotto scarne pietre tombali. Magica, per il colpo d’occhio che allontana dal mondo noto. È un luogo insieme da brivido, perché ricorda l’orrore di una guerra devastante, e di pace, perché i clamori sono lontani, come acquietati nella calma e nel silenzio del paesaggio, rotto solo da qualche cicala.
Dopo l’interruzione del 2020, causata dalla pandemia, Archivio Zeta torna a rappresentare spettacoli in questo luogo. E vi ambienta La montagna incantata di Thomas Mann, romanzo del 1924, usando il vecchio titolo, entrato nella memoria, e non quello più preciso dell’edizione dei Meridiani Mondadori, La montagna magica (Der Zauberberg), avvertendo la stessa traduttrice Renata Colorni che forse più preciso sarebbe: La montagna incantante.
Il luogo che accoglie il sanatorio del romanzo, Davos, in Svizzera, nel Canton Grigioni, è proprio lo stesso del World Economic Forum. Ma nel romanzo di Mann siamo agli antipodi della globalizzazione: ci troviamo su una montagna che isola, dalla pianura e dal tempo dell’attività, dalla storia, che sprofonda nella malattia, nei riti del corpo e dell’ossessione della cura, nell’ansia di una malattia che è anche affezione della società, che sfocerà nel finale del libro nel massacro nel fango della Grande Guerra.
Teatri dei luoghi
Ho visto La montagna incantata di Archivio Zeta alla fine della mia estate di vagabondaggi teatrali. Subito dopo un altro spettacolo legato strettamente a un luogo, quello del Teatro Povero di Monticchiello, definito dai critici e dai suoi autori, ormai anni fa, “autodramma”, perché porta in scena tutti gli abitanti del piccolo borgo toscano, inscenando qualche momento della storia collettiva o qualche nodo problematico del presente. L’anno scorso è scomparso Andrea Cresti, che per anni aveva animato quei lavori, collaborando alla scrittura dei copioni firmati “Gente di Monticchiello”, curandone la regia. Il suo testimone è stato raccolto da Giampiero Giglioni e Manfredi Rutelli, ma lo spettacolo di quest’anno, Ultima chiamata, pur radicato in alcuni temi e moduli espressivi cari a questa manifestazione, ancora non vola. Difficile è raccogliere un’eredità.
La vicenda va avanti e indietro nel tempo, tra civiltà contadina, conflitti politici del 1956, momenti di un presente virato verso la distopia e verso un futuro dove appare necessario riannodare i fili dell’azione, della partecipazione. Un ruolo particolare assumono le donne del paese: tenute ai margini dagli uomini nelle scene situate del passato, anche loro ridotte a caricature folcloristiche in un presente televisivo con spolverate di recupero della civiltà contadina, prendono coscienza che devono essere loro ad assumersi la responsabilità di parlare in prima persona. Mancano i toni favolistici che hanno caratterizzato le opere più riuscite della pluridecennale storia di questa manifestazione, e tutto suona un po’ troppo di maniera, senza le invenzioni che in certi anni hanno reso godibile questa messa in scena dell’immaginario di un intero paese, un tempo agricolo ora principalmente agrituristico, nel suo luogo centrale, la piazza a imbuto digradante.
Si replica fino al 14 agosto.

Il riottoso figlio della vita di Archivio Zeta
Fino al 21 agosto invece replica lo spettacolo di Archivio Zeta (sempre alle 18; prenotazioni: archiviozeta.eu), che è solo la prima parte del fluviale, composito romanzo di iniziazione di Thomas Mann, con drammaturgia e regia di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni. Non finiremo mai di ammirare il coraggio di questa compagnia, che per questa serie di intensi spettacoli, ambientati nel Cimitero ormai dal 2003, conta solo sugli introiti del botteghino, senza mai concedere nulla alla moda o alle necessità di cassetta, in un’idea di teatro civile mutuata da Pasolini. Un Pasolini che torna nell’altro spazio animato da Archivio Zeta, la neoclassica villa Aldini, da cui si domina tutta Bologna. Là, insieme a un’attività che si prolunga fino all’autunno, è ospitata una mostra sull’ultimo film di Pasolini, Salò, in parte girato proprio in quel sito.
Nello spettacolo tratto dal romanzo di Mann si narra l’arrivo a Davos di Hans Castorp, giovane laureato in ingegneria di Amburgo, per visitare il cugino rinchiuso in un sanatorio dove si cura la tubercolosi. Il luogo sprigiona un fascino sinistro, alimentato da medici, infermieri, suore, che vedono come una missione lo scoprire la malattia e separare giovani e meno giovani dalla vita del mondo, sottoponendoli a cure regolari, quotidiane, lente. Quel fascino si riverbera sulla rassegnazione dei malati a sottoporsi a cure dagli esiti dubbi, un po’ crogiolandosi nella loro condizione di separati dalla vita attiva.
Le tre settimane progettate da Castorp per la visita al cugino si dilateranno fino all’insorgere una febbre che lo fa assumere nel mondo sospeso dei malati. L’universo concluso di Davosplatz è il negativo del mondo in subbuglio, dove Castorp dovrebbe entrare per cominciare la professione: la sosta rappresenta anche la paura dell’ingresso nella vita adulata, con tutto quello che ne consegue.
Nell’azione concertata da Archivio Zeta, Enrica Sangiovanni si riserva, con ironia, la parte della bellissima, seducente Claudia Chauchat dagli occhi kirghisi, mentre l’altro fondatore della compagnia, Gianluca Guidotti, si presenta come un Settembrini dall’aspetto un po’ folle, radicale e liberale, sostenitore di un mondo nuovo, amico di poeti, dall’aria alquanto stralunata, primo mentore di Castorp, definito “riottoso figlio della vita”, perché non vuole accettare questa cesura dal mondo, anche se alla fine si lascia irretire dall’incantesimo di questa sospensione del tempo, che rammenta anche quella del Venusberg, la montagna incantata dove si è rifugiata la dea dell’amore dopo l’irrompere del cristianesimo e dove tiene corte di piaceri.

Tra psicanalisti che insegnano come la malattia sia sfogo dalla repressione degli istinti vitali, medici che sperimentano metodi di diagnosi e cura all’avanguardia, sempre al confine con la magia, infermieri, caposala simili a kapò o a automi dal comportamento meccanico e inderogabile, l’azione si dipana negli spazi del Cimitero germanico, salendo verso il fortilizio con la scultura a forma di ala ripiegata dopo il volo, fino alla cripta, che diventa camera oscura dove si mostrano radiografie di polmoni infettati, marci, consumati… Poi di nuovo fuori.

Il finale è una scena straordinaria, che segue il tramonto del sole tra le cime dei monti, tra abbaglianti controluce dell’astro, nere silhouette, apparizioni di figure di sogno o incubo in un carnevale in cui Castorp capisce che l’amore può vincere la malattia e ha un contatto, fugace, con la bella Claudia, un rapporto che presto si interromperà perché lei abbandonerà il sanatorio, la reclusione. È una scena che si incista tra il sogno e il desiderio, con il fremere del corpo, lo stesso che produce la voluttà e la morte, che prova continuamente a superare la morte illudendosi con la corruttibile bellezza.
Il tema, forte, è quello: la virulenza devastante e il fascino della malattia, come la pandemia che abbiamo attraversato, l’abbandonarsi a essa, renderla un tempo altro da cui fuggire e in cui crogiolarsi, la fuga dal mondo, il desiderio, l’amore e tutto quello che reprimiamo o scarichiamo – proiettiamo – altrove. Anche nei discorsi nutriti da ogni tipo di ideologia, come fa Settembrini e come faranno altri, diversi, mentori di Castorp, affascinandolo e sempre un po’ rapinandolo. La malattia, o la paura di essa, che ci rende fragili, e l’amore che ci trasfigura verso l’infinito: anche solo per (auto)illusione.

Lo spettacolo rappresenta solo cinquecento pagine del libro, la metà più o meno esatta. Si sviluppa tra parti narrative, momenti di collegamento, spostamenti del pubblico nel Cimitero, suggestioni in relazione con il paesaggio, meditazioni, momenti grotteschi o onirici, in un insieme maturo, insieme dialettico e coinvolgente, con la presenza costante del violoncello di Francesco Canfailla e di incisivi interventi musicali composti da Patrizio Barontini. La compagnia, oltre che con i giovani Guidotti, Elio, Antonia e Ida, in un’idea antica di famiglia d’arte, si dilata in questa occasione con giovani, bravi attori formatisi alla scuola Nico Pepe di Udine (ma molti sono cresciuti a Bologna).
Giacomo Tamburini è un Castorp compreso e stupito, perfetto giovane protagonista di una sospensione del tempo che sembra ispirata anche dalla teoria della relatività; Diana Dardi scolpisce con ottime caratterizzazioni la Signorina Engelhart e la Superiora Von Mylendonk, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco e Andrea Maffetti completano la costellazione dei personaggi di questo mondo autoreferenziale, in attesa di esplosione. La tecnica è di Andrea Sangiovanni, i costumi di les libellules Studio in collaborazione con Elena Fregni.
Le fotografie sono di Franco Guardascione.